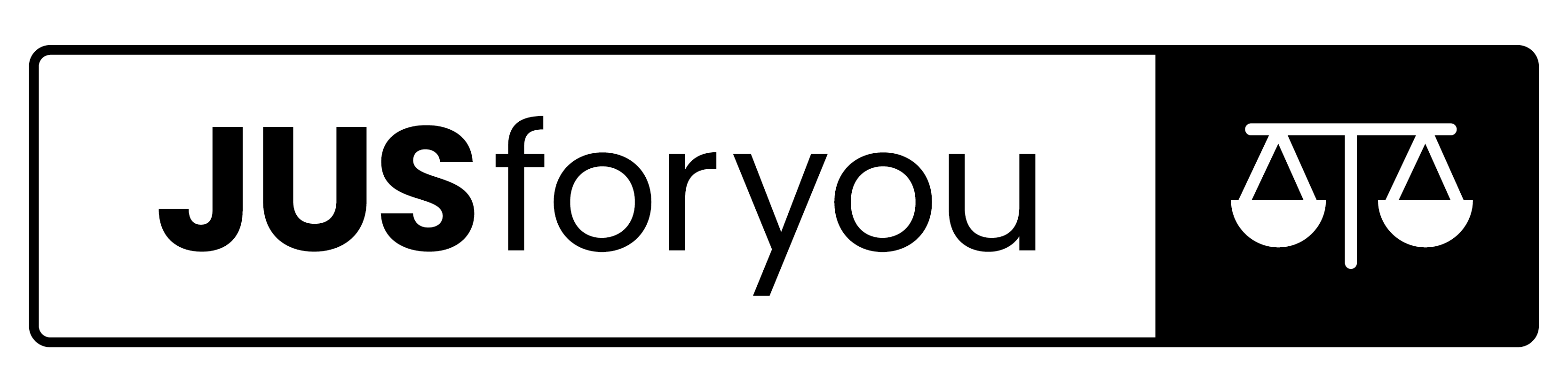Cass. Sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 3755 – Pres. De Amicis, Rel. Paternò Raddusa
Il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio, previsto dall’art. 326, co. 1 c.p., costituisce un reato proprio e punisce unicamente il propalatore qualificato (pubblico ufficia le o Incaricato di pubblico servizio) della notizia riservata e non il soggetto che la riceve, salvo che quest’ultimo non si sia limitato passivamente a riceverla ma abbia, con il proprio contegno. contribuito al disvelamento illecito, istigando, inducendo o comunque supportando l’intraneus nella esecuzione del la relativa condotta materiale, così realizzando un concorso morale nel reato.
In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, il contenuto di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese – nel corso di un’indagine già in corso – da un indagato in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero procedente, integra una notizia d’ufficio che deve restare segreta e, pertanto, l’oggetto materiale della condotta del delitto di cui all’art. 326, co. 1 c.p. La sede di acquisizione delle relative dichiarazioni, infatti, rende le notizie riferite e i relativi atti di verbalizzazione ontologicamente coperti dal segreto investigativo; ancor più quando, riguardando anche la posizione di terzi diversi dal dichiarante potenziale imputato, gli atti siano stati segretati ex art. 329, co. 1 e 3 c.p.p., perché esondanti la posizione del solo dichiarante.
In ipotesi di violazione del segreto investigativo, l’onere di riservatezza della notizia risulta imposto ex lege dall’art. 329 c.p.p. a prescindere dalla concreta incidenza che abbia assunto il disvelamento rispetto all’ordinario e utile sviluppo dell’indagine. Il delitto di cui all’art. 326 c.p. si configura come reato di pericolo presunto e sussiste senza che possa sorgere questione circa l’esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa (impositiva del segreto) ha già effettuato la valutazione circa l’esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell’obbligo del segreto.
Dall’offensività in sé della condotta di rivelazione consegue, quale logico corollario, l’indifferenza di qualsivoglia indagine in fatto diretta ad accertare la positiva incidenza della rivelazione.
In tema di concorso di persone nel reato, l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo in capo al concorrente “intraneo” nel reato proprio – giudicato in altro procedimento e assolto per incolpevole errore su norma extrapenale – non esclude di per sé la responsabilità del concorrente ‘estraneo’, che resta punibile nei casi di autorìa mediata di cui al l’art. 48 c.p. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo il concorrente “intraneo”· e non sia quindi estensibile alla posizione dell’extraneus.
Da un lato, infatti, il concorso di persone nel reato è configurabile anche quando uno dei concorrenti non è punibile per difetto di imputabilità o comunque di colpevolezza (artt. 46, co. 2, 48, 111, 112, ult. co., 119 c.p.); dall’altro lato, dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle del concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti, aventi in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma suscettibili di autonoma considerazione riguardo all’atteggiamento psichico di ciascuno dei compartecipi. Ciò alla luce dell’assorbente centralità comunque da assegnare, anche nei reati propri, al fatto tipico principalmente riferito normativamente all’autore qualificato, considerato nella sua oggettiva materialità e prescindendo dalla colpevolezza dell’intraneus, così da recuperare, all’area della responsabilità penale, tutte le condotte partecipative atipiche che a quel fatto accedono e che si risolvono in una indebita strumentalizzazione della posizione del concorrente qualificato.
In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ribadito che la fattispecie di cui all’art. 326, co. 1 c.p. punisce unicamente il propalatore della notizia riservata (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), e non il soggetto che la riceve, un’interpretazione conforme ai principi di legalità e di tassatività (art. 25, co. 2 Cost.) suggerisce di non dare continuità alle opzioni ermeneutiche basate sulla automatica punibilità di colui che abbia ricevuto la notizia ove in seguito la riveli a terzi. sempre che la notizia stessa abbia conservato il suo carattere segreto. Nondimeno, se l’extraneus che ha ricevuto la notizia (da un pubblico ministero) la rivela, agendo a sua volta in veste di pubblico ufficiale (Consigliere del CSM), tale successiva divulgazione può in via di principio integrare un autonomo fatto rilevante ex art. 326, co. 1 c.p. se la condotta è posta in essere in violazione dei doveri inerenti la funzione o comunque abusando della sua qualità.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dato integrale conferma alla sentenza del Tribunale locale con la quale A.A. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile, B.B., perché ritenuto responsabile di più fatti di reato puniti ai sensi dell’art. 326 cod. pen., avvinti dalla continuazione.
2. In particolare, secondo le due conformi valutazioni rese dai Giudici del merito, l’imputato, all’epoca dei fatti componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per un verso avrebbe concorso, rafforzandone il proposito, nella rivelazione sanzionata ex art 326, comma 1, cod. pen. materialmente commessa da C.C., Sostituto procuratore in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, separatamente giudicato e assolto per la ritenuta insussistenza del dolo.
Rivelazione, questa, realizzata dando notizia, per l’appunto al A.A., delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’Avvocato F.F. nel corso delle indagini relative al procedimento n. 12333/17, consegnando anche al concorrente un supporto informatico contenente copia in word dei relativi verbali (inerenti alle propalazioni rese tra il 16 dicembre 2019 e l’11 gennaio 2020). Il tutto con riguardo a notizie e atti coperti dal segreto investigativo nei quali il dichiarante faceva riferimento alla presunta esistenza di una associazione segreta di matrice massonica della quale avrebbero fatto parte, tra gli altri, alte cariche dello Stato e delle Forze Armate nonché diversi magistrati e in particolare, due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
Per altro verso, A.A., una volta entrato nella disponibilità di tali notizie e atti coperti da segreto, ne avrebbe divulgato a terzi il contenuto, consegnandone copia a E.E., componente del Consiglio Superiore della Magistratura e al Vicepresidente del medesimo organo, D.D.; e riferendone il portato alle sue collaboratrici amministrative G.G. e H.H., ai Consiglieri I.I., J.J., K.K. e L.L. (al quale ebbe a consegnare copia dei detti verbali), nonché al Senatore M.M., Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, e al Presidente della Corte Suprema di Cassazione, N.N..
3. Propone ricorso la difesa dell’imputato e, dopo una premessa di tipo storico – diretta ad evidenziare che dei diversi soggetti attinti da procedimenti penali comunque correlati alle iniziative giudiziali conseguenti alla acquisizione delle dichiarazioni di F.F., compreso lo stesso C.C., autore della prima rivelazione, l’unico condannato era stato il solo A.A. -, deduce trenta motivi di censura, volti a contrastare la configurabilità del reato in contestazione sotto il versante dei relativi costituti oggettivi e la sussistenza del dolo, nonché a rassegnare diversi travisamenti probatori, alcune violazioni in punto di rito, mettendo altresì in discussione le valutazioni rese a sostegno della conferma della decisione gravata anche in relazione alle statuizioni rese in favore della parte civile.
4. Con i primi otto motivi si contesta la violazione di legge in relazione all’art. 326 cod. pen. e diversi vizi di motivazione avuto riguardo alla ritenuta configurabilità dell’ipotesi di reato ascritta al ricorrente.
In particolare, si rimarca che le emergenze in fatto attestavano che sino al 12 maggio 2020, malgrado le prime dichiarazioni di F.F. risalissero al dicembre precedente, non era stata formalizzata alcuna iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen riguardo alle ipotesi di reato correlate alle dette propalazioni; e tanto per le remore in tal senso frapposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, O.O., dal Sostituto procuratore della Repubblica co-assegnatario dell’indagine e da altro Magistrato del Pubblico Ministero che curava una indagine collegata.
C.C., dunque, nell’aprile del 2020 non avrebbe comunicato a A.A. notizie inerenti ad una indagine in corso, ma avrebbe piuttosto rassegnato l’assenza della necessaria formalizzazione della relativa iscrizione, ragione effettiva della iniziativa messa in atto contattando l’imputato. Da qui la astratta non configurabilità del reato.
La Corte territoriale, poi, avrebbe travisato il materiale probatorio acquisito nel ritenere, a differenza di quanto statuito nel giudizio separatamente reso ai danni di C.C., che sulla iscrizione della notizia di reato in questione, operata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale l’intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, P.P., che con il primo ebbe a colloquiare sui temi inerenti alle dichiarazioni di F.F. proprio in esito alla scelta di A.A. di compulsarlo in tal senso dopo aver ricevuto la segnalazione da C.C.
Di contro, la scansione temporale accertata dal processo darebbe conto: a) del contatto intercorso tra C.C. e A.A.; b) dell’avviso dato da quest’ultimo a P.P. rispetto all’inerzia mostrata dall’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano rispetto all’iscrizione in questione; c) della interlocuzione avvenuta tra P.P. e O.O. e quindi dell’iscrizione operata da quest’ultimo.
La configurabilità dell’ipotesi di reato contestata, ancora, dovrebbe escludersi, ad avviso della difesa, considerando che a rivelare la notizia era stato lo stesso Sostituto procuratore della Repubblica che, ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., aveva segretato i citati verbali di interrogatorio: verbali che, oltre a contenere accuse rivolte a sé stesso da parte di F.F., avevano un contenuto etero-accusatorio e, dunque, coinvolgevano terzi possibili indagati.
La segretazione in questione sarebbe stata operata, del resto, in termini di marcata abnormità, perché non correlata ad alcuna iscrizione della relativa notizia di reato alla quale l’ufficio inquirente doveva obbligatoriamente procedere quantomeno nei confronti di F.F. e rispetto alla quale lo stesso era rimasto per più mesi colpevolmente inerte; e che risultava apposta, peraltro, in assenza di qualsivoglia motivazione, così da risultare anche affetta da nullità assoluta.
Da qui la non vincolatività del segreto, comunque rimosso dallo stesso soggetto che lo aveva illegittimamente apposto.
Né il segreto poteva ritenersi legittimamente apposto facendo riferimento all’attività di indagine e dunque al procedimento nel corso del quale le dichiarazioni erano state acquisite, relativo ad altri fatti, mentre, per quelli riferiti dall’F.F. in quelle occasioni, non si era neppure proceduto ad un aggiornamento della relativa iscrizione originaria.
Del resto, avendo la Corte del merito ritenuto la responsabilità di A.A. siccome concorrente alla condotta di rivelazione resa da C.C., le successive azioni di divulgazione di un segreto già violato, ad avviso della difesa, darebbero corpo ad un postfatto non punibile, perché dopo la prima condotta il segreto avrebbe cessato di essere tale; e ciò a differenza del caso citato dalla sentenza gravata, là dove la condotta di divulgazione dell’extra neus valorizzata dalla sentenza di legittimità evocata dalla Corte territoriale riguardava un soggetto che non aveva concorso nella rivelazione del segreto contestata ali’intraneus.
Peraltro, la sentenza impugnata cadrebbe in una grave contraddizione anche in considerazione dell’assoluzione di C.C., perché per effetto dei due giudizi separati la comunicazione resa da quest’ultimo non sarebbe stata ritenuta illecita, se non per il solo contegno ascritto a A.A., mentre la condotta propalativa di quest’ultimo resa in direzione del Vicepresidente D.D. integrerebbe il reato contestato, a differenza di quanto comunicato al Procuratore generale P.P., contegno rispetto al quale non vi sarebbe stata neppure contestazione.
Per altro verso, la Corte territoriale, seguendo il primo Giudice, avrebbe ritenuto il concorso del ricorrente nella condotta di rivelazione resa da C.C. perché A.A., all’evidenza più esperto nella conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe indotto in errore l’intraneus quanto alla ritenuta inopponibilità del segreto all’organo di autogoverno. Ma una siffatta impostazione sarebbe distonica rispetto al tenore della imputazione, che, senza fare alcun riferimento alla ipotesi di cui all’art. 48 cod. pen., faceva leva sul rafforzamento del proposito criminale dell’intraneus garantito dalla condotta dell’imputato, proposito poi non riscontrato nel giudizio autonomamente reso nei confronti del concorrente.
Da qui la violazione dell’art. 110 cod. pen., ma anche il vizio inerente alla mancata correlazione tra accusa e sentenza, in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
5. La difesa, con il motivo addotto per nono, lamenta la non configurabilità del reato di cui all’art. 326 cod. pen. perché sia C.C., prima, che A.A., poi, si sarebbero limitati a riferire notizie segretate a soggetti componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organo al quale il segreto investigativo non poteva ritenersi opponibile.
Si rimarca che, prima del disvelamento ai media dei citati verbali, nessuno dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda in questione (e in particolare, né il Procuratore Generale della Cassazione, né quello della Repubblica presso il Tribunale di Milano, né infine i diversi componenti del Consiglio destinatari dei disvelamenti operati da A.A.), ritennero illecita la relativa divulgazione. Ciò, del resto, in linea con le valutazioni rese in sede di archiviazione delle accuse mosse nei confronti dei Consiglieri E.E. e J.J. (per non aver denunziato la rivelazione resa da A.A.), nonché con l’opinione in tal senso espressa dai diversi Consiglieri coinvolti dall’agire del ricorrente, escussi nel corso del giudizio.
Del resto, come puntualmente evidenziato dallo stesso imputato nel corso del suo esame, le dichiarazioni rese da F.F. coinvolgevano direttamente l’azione del Consiglio Superiore della Magistratura, perché mettevano in dubbio la legittimità di numerose nomine dirigenziali e di incarichi semidirettivi resi nella precedente consiliatura (assertivamente asservita all’influenza della loggia massonica cui aveva fatto riferimento F.F.), tanto da legittimare l’ipotesi di una eventuale iniziativa in autotutela, da attivare in tempi piuttosto stringenti rispetto alle delibere da scrutinare nuovamente.
E proprio tali risvolti, alla luce del contenuto della circolare consiliare del 15 gennaio 1994, n. 510, imponevano di riferire immediatamente il dato offerto dalle dette dichiarazioni al Consiglio, e dunque ai suoi componenti, prescindendo dal segreto investigativo, anche per consentire allo stesso di svolgere appieno il potere di inchiesta eventualmente funzionale a possibili trasferimenti d’ufficio ex art 2, comma 2, R.D.Lgs. n. 511 del 1946.
Il coinvolgimento del Consiglio Superiore, dunque, non poteva ritenersi unicamente subordinato al riscontro di atti di indagine coperti da segreto resi in un procedimento penale che vedesse coinvolti magistrati, circostanza esclusa nella specie dal tenore della relativa iscrizione (resa all’epoca senza coinvolgere Magistrati), ma erroneamente messa in luce dai Giudici del merito nel ritenere eccentrica la condotta di C.C. prima e di A.A. poi. Che, dunque, il Consiglio (e con esso i suoi componenti e lo stesso personale amministrativo che lavorava a fianco del A.A.) dovesse ritenersi legittimo destinatario della notizia rivelata, aspetto destinato ad escludere l’illiceità della condotta dei due concorrenti, era conclusione, oltre che corretta in diritto, anche confermata dalla relativa prassi amministrativa, come ribadito anche dal teste K.K. nel corso del relativo giudizio. L’agire in contestazione, inoltre, doveva ritenersi privo di concreta offensività, come confermato dalla decisione del Consiglio superiore della Magistratura di rigettare la richiesta cautelare di trasferimento ad altro ufficio di C.C. nel parallelo procedimento disciplinare promosso ai suoi danni.
6. Con i motivi dedotti per decimo, undicesimo e dodicesimo, la difesa contesta la tenuta della decisione gravata anche sul versante della compiutezza e della logicità della motivazione adottata nella parte in cui risulta valorizzata non la comunicazione in sé della notizia coperta da segreto ai componenti del Consiglio, bensì la modalità della relativa comunicazione, perché non proveniente dagli organi a ciò preposti oltre che non realizzata secondo le indicazioni formali dettate dalla normativa secondaria di riferimento (invio in plico chiuso al Comitato di Presidenza del Consiglio). Ciò trascurando l’insieme di acquisizioni probatorie dirette ad evidenziare che la strada informale privilegiata da A.A. era l’unica che consentiva di mantenere riservata la notizia senza farne conoscere il contenuto ai due componenti del Consiglio coinvolti dalle propalazioni di F.F. e, in particolare, al Consigliere B.B., che, della prima Commissione del Consiglio, naturale destinataria della vicenda una volta scrutinata dal Comitato di Presidenza, era all’epoca il Presidente.
7. Con i motivi rubricati per tredicesimo e quattordicesimo, si lamenta la non configurabilità della ipotesi di reato contestata per l’assenza di un nocumento effettivo arrecato alla indagine in conseguenza della rivelazione in questione, considerando anche quanto messo in evidenza dalle argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nel disporre l’archiviazione del procedimento promosso in esito alle dichiarazioni di F.F.
Né potrebbe valorizzarsi, ad avviso della difesa, il riferimento, nel propalato del dichiarante, alla persona del Consigliere J.J., destinatario di una delle divulgazioni operate da A.A.: al suddetto, infatti, non venivano attribuite azioni illecite da parte di F.F. (essendo stato, al più, destinatario inconsapevole di favori), sicché egli non poteva dirsi interessato al merito della relativa indagine, così da interferire sulla stessa.
8. Con i motivi addotti per quindicesimo e sedicesimo, e sempre con riguardo al tema della effettività del pericolo connesso alla divulgazione contestata, la difesa adduce la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e vizio di motivazione per avere i Giudici del merito ricondotto all’imputato la diffusione, nel 2021, delle notizie riferitegli da C.C.
Diffusione – verificatasi in esito alla trasmissione dei verbali di F.F. a due giornalisti e al Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Q.Q., che ebbe a parlarne al Plenum, favorendo così la definitiva propalazione mediatica delle notizie in questione – alla quale il ricorrente, come attestato dalle acquisizioni probatorie (in particolare dalle chat delle due collaboratrici dell’imputato), è rimasto del tutto estraneo, sicché, per tale disvelamento, doveva escludersi ogni nesso di causalità rispetto alle condotte a lui ascritte.
9. Con i motivi addotti dal diciassettesimo al ventunesimo si contesta il giudizio di responsabilità legato alla asserita rivelazione dal ricorrente fatta al Presidente della Commissione parlamentare antimafia. Ciò sotto il versante della non configurabilità del reato contestato, perché l’imputato non ebbe mai a riferire al M.M. che vi era una indagine, non ebbe a segnalarne i tratti indentificativi, né ad indicare la fonte dichiarativa della notizia, ossia dell’appartenenza di B.B. ad una loggia massonica. Tale notizia, del resto, venne riferita al predetto nella sua qualità istituzionale, come confermato dai due verbali di sommarie informazioni testimoniali allegati nel corso del giudizio di appello, ma non acquisiti dalla Corte territoriale, sul presupposto della loro inutilizzabilità, con valutazione illegittima a fronte del consenso al loro utilizzo espressamente reso da parte dell’imputato.
Né, peraltro, le dichiarazioni di M.M., per come apprezzate dai Giudici del merito, potrebbero sostenere il giudizio di responsabilità, in considerazione della genericità del dato riportato, sotto altro profilo contraddetto dalle ulteriori acquisizioni probatorie e travisato nel suo effettivo contenuto (perché mai M.M. avrebbe dichiarato di aver visto i verbali). Del resto, la notizia sarebbe stata divulgata nei confronti di un soggetto comunque tenuto al segreto, considerati i compiti e i poteri della Commissione parlamentare presieduta da M.M.
Assume la difesa, inoltre, quanto alla condanna resa in relazione a tale condotta, che vi sarebbe un difetto di correlazione tra l’imputazione (che contestava a A.A. di aver riferito a M.M. che vi era una indagine in corso su una presunta loggia che vedeva tra i partecipi B.B.) e la sentenza, che avrebbe dichiarato la relativa responsabilità in difetto di elementi utili a confermare l’assunto accusatorio, poiché le emergenze acquisite davano conto della mera indicazione del fatto che B.B. risultava tacciato di appartenere ad una associazione segreta, senza fare cenno ad una indagine diretta ad accertarne l’effettiva intraneità.
La confidenza resa a M.M., infine, per il contenuto della propalazione, non era comunque in grado di incidere sulla genuinità dell’indagine, proprio per la genericità del dato riferito.
10. Con i successivi motivi prospettati sino al ventiquattresimo, la difesa contesta, replicando una censura già svolta in sede di appello con apposito motivo aggiunto, la ritenuta continuazione della condotta realizzata rivelando la notizia coperta da segreto a M.M. con le altre precedenti condotte.
Si assume, al riguardo, che ritenere tutte le condotte avvinte dalla comune egida di un medesimo e programmato disegno criminoso, oltre ad incidere sulla intensità del dolo valorizzata nel determinare la pena, finirebbe anche per contraddire la tesi difensiva della buona fede dell’imputato sia in ordine alla ritenuta non opponibilità del segreto al C.S.M. e, per esso, ai suoi componenti (proprio perché M.M. ne era estraneo), sia alla sua intenzione di riportare l’indagine correlata alle dichiarazioni di F.F. all’interno dei binari della legalità (perché M.M. non avrebbe potuto svolgere in tal senso alcun ruolo, a differenza dei componenti del C.S.M.).
11. Con il venticinquesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 32 bis della legge n. 195 del 1958, avuto riguardo alle conversazioni intervenute con gli altri componenti del Consiglio Superiore della Magistratura quanto alla possibile apertura di una procedura in autotutela diretta al riesame delle nomine inerenti ad uffici direttivi e semidirettivi deliberati dal procedente Consiglio quale conseguenza delle dichiarazioni rese da F.F..
12. Con i motivi addotti per ventiseiesimo e ventisettesimo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta non applicabilità alla specie dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., quantomeno in termini meramente putativi, nonché in ordine alla ritenuta insussistenza di un errore di fatto correlato alla corretta interpretazione della normativa processuale e ordinamentale.
Si evidenzia, sotto tale profilo, che la particolarità della vicenda riferita da C.C. ben legittimava nel ricorrente, quantomeno sul piano putativo, l’idea che sullo stesso incombesse l’onere di compulsare non solo il Procuratore generale della Corte di Cassazione ma tutti gli altri componenti del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura anche al fine di ottenere puntuali indicazioni sul modo di affrontare una situazione talmente singolare che, anche per un Magistrato della sua esperienza, doveva ritenersi difficile da trattare.
L’incertezza del dato normativo, anche secondario, di riferimento e delle correlate interpretazioni, ma anche lo stesso atteggiamento tenuto dai diversi soggetti che a livello istituzionale furono coinvolti senza mai paventare l’ipotesi della rivelazione contestata, davano corpo alla scusabilità dell’errore in cui ebbe a cadere il ricorrente nel decidere di percorrere la strada poi seguita nell’occasione.
13. Con il motivo addotto per ventottesimo, si contesta il giudizio reso sulla configurabilità del dolo, letto in comparazione con la analoga valutazione separatamente resa per C.C. da altro Collegio della medesima Corte di appello.
La rivelazione resa da quest’ultimo a A.A. è stata ritenuta in buona fede perché il ricorrente intendeva solo smuovere una situazione di inerzia che percepiva come illegittima; al contempo, ad avviso della difesa, non si vede per quale ragione l’aver riportato tale dato agli esponenti di maggior peso dell’organo di autogoverno della Magistratura sia condotta che, sotto il versante soggettivo, debba essere valorizzata in modo diverso.
Né potrebbe addursi a sostegno di tale distinguo la specifica intenzione dell’imputato di voler danneggiare B.B. facendo credere ai suoi interlocutori che le dichiarazioni di F.F. fossero veridiche, pur se consapevole della loro falsità. Tale dato, infatti, risultava smentito dal tenore delle stesse decisioni di merito con le quali è stata conformemente esclusa l’intenzione di A.A. di voler nuocere al Consigliere B.B.
14. Con gli ultimi due motivi di ricorso si lamenta il travisamento delle emergenze probatorie là dove, nel sostenere la presenza di un danno arrecato alla parte civile, si trascura di considerare che nessuno dei testimoni escussi avrebbe affermato che, in esito alle propalazioni rese dal ricorrente, B.B. venne isolato o comunque osteggiato all’interno del Consiglio: aspetto, questo, confermato dallo stesso atteggiamento tenuto dalla parte civile allorquando, circa un anno dopo le condotte riferite all’imputato, venne a sapere che diversi Consiglieri erano già stati portati a conoscenza delle dichiarazioni di F.F..
Né si può affermare, ad avviso della difesa, che A.A. avrebbe attribuito colpevolezza certa all’intraneità di B.B. rispetto alla loggia massonica indicata da F.F. pur avendo consapevolezza della falsità della relativa accusa, perché l’atteggiamento tenuto dall’imputato, sin dall’inizio, era volto ad accertare, tramite una indagine, l’eventuale fondatezza o meno di tali propalazioni, il che dà conto di un comportamento del tutto contrario rispetto a quello oggetto di contestazione.
15. La difesa ha altresì proposto motivi aggiunti e in particolare sette altri motivi con memoria trasmessa via p.e.c. il 24 ottobre del 2024 e un ulteriore motivo con memoria inviata alla Cancelleria di questa Suprema Corte il 14 novembre 2024.
16. Con la prima memoria la difesa, a sostegno ed ulteriore precisazione dei motivi addotti per primo, sesto, ventiseiesimo e ventottesimo del ricorso originario, ha evidenziato che, dopo il deposito del ricorso, sono intervenute due decisioni – all’epoca note solo nel relativo dispositivo – tali da confermare che, nell’occasione, l’iniziativa assunta da C.C. e poi da A.A. trovava ragion d’essere nella convinzione che fosse un loro dovere attivarsi in tal senso a fronte dell’inerzia mostrata dall’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel dare il giusto impulso all’attività di indagine conseguente alle dichiarazioni rese da F.F.
La difesa si riferisce, in particolare, all’assoluzione (disposta dal Tribunale di Milano) di F.F. dall’accusa di calunnia realizzata ai danni del Consigliere R.R. (tanto da poter ribadire che le relative dichiarazioni meritavano comunque un approfondimento poco compatibile con la situazione di stallo rassegnata da C.C.); alla condanna (resa dal Tribunale di Brescia) dei Sostituti Procuratori della Repubblica che curavano l’accusa nel processo Eni/Shell-Nigeria per rifiuto di atti d’ufficio, per non aver depositato prove favorevoli alla difesa (tra questi il dott. T.T. che, a dire di C.C., era contrario alla iscrizione ex art 335 cod. proc. pen. delle notizie di reato conseguenti alle dichiarazioni di F.F.).
16.1. Ancora, a supporto dei motivi originari addotti per terzo e quarto, e dal nono al dodicesimo, si ribadisce l’indifferenza del dato inerente alla corretta trasmissione, sul piano formale, al Consiglio Superiore della Magistratura, di una notizia coperta da segreto una volta che si ritenga quest’ultimo non opponibile al detto organo e dunque ai suoi componenti.
16.2. Con il terzo motivo aggiunto si ribadisce l’intima contraddittorietà della decisione gravata là dove distingue la segretezza della notizia a seconda del destinatario della stessa, dando luogo a valutazioni distoniche a fronte di comportamenti sostanzialmente analoghi.
16.3. Con i motivi aggiunti addotti per quarto e quinto, ad integrazione di quelli originari rubricati per quinto, sesto e settimo, si evidenzia inoltre che l’imputazione e la stessa motivazione danno unicamente conto della qualifica soggettiva del ricorrente (componente del Consiglio Superiore), ma nulla evidenziano rispetto alla violazione dei doveri o all’abuso della qualità che la fattispecie incriminatrice in esame comunque impone, avuto riguardo alle condotte diverse da quella immediatamente afferente al concorso con lo C.C..
16.4. Con il sesto motivo aggiunto, a specificazione delle osservazioni critiche rese con i motivi originari addotti dal ventiseiesimo al ventottesimo, si ribadisce l’inadeguatezza della motivazione sottesa al dolo ascritto al ricorrente riguardo a tutte le condotte allo stesso contestate quando, nel caso, proprio la buona fede riconosciuta, in più situazioni processuali, a tutti i protagonisti della vicenda che occupa, e in primo luogo allo C.C., imponeva uno scrutinio puntuale e coerente delle diverse ragioni giustificative di volta in volta indicate dall’imputato in relazione alle diverse ipotesi di rivelazione ritenute in sentenza.
Le due sentenze di merito, peraltro, nell’escludere la buona fede del ricorrente, avrebbero ricostruito in termini difformi l’obiettivo perseguito da A.A., per forza di cose unitario a fronte della continuazione riconosciuta.
In particolare, la prima sentenza sarebbe contraddittoria rispetto al materiale probatorio acquisito, oltre che in relazione al percorso logico seguito (perché l’intenzione di screditare B.B. sarebbe stata smentita dall’affermazione diretta a precisare che, nel caso, l’azione dell’imputato non sarebbe stata connotata da animus nocendi); la seconda sarebbe apodittica (nel ritenere l’imputato consapevole di gettare una luce sinistra sull’operato della Procura di Milano e sui due colleghi del Consiglio coinvolti dalle dichiarazioni di F.F.).
Oltre a ribadire le considerazioni già svolte nel ritenere applicabile alla specie l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., anche in termini meramente putativi, la difesa lamenta l’assoluta assenza di congrue argomentazioni rispetto alle ragioni che avrebbero giustificato nel caso in esame la condotta materiale dell’imputato.
16.5. Con il settimo motivo si ribadiscono e precisano le argomentazioni esposte con il ricorso originario a sostegno della illogicità del ragionamento sotteso al riconoscimento della continuazione a fronte di condotte che non potevano dirsi sostenute dal requisito della unicità del medesimo disegno criminoso.
17. Con la memoria inviata il 14 novembre 2024, la difesa, nel proporre un ulteriore motivo aggiunto, ha nuovamente contestato la decisione impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo, segnalando ancora una volta l’assenza di una puntualizzazione quanto alle ragioni che nel caso avrebbero giustificato le condotte illecite ascritte al ricorrente, profilo, questo, valorizzato per stigmatizzare il difetto di radicale logicità della valutazione resa sul punto.
18. Infine, nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria difensiva pervenuta presso questa Corte il 27 novembre del 2024 ed ancora una volta diretta a mettere in evidenza che la reale intenzione dell’imputato non era altro che quella di “riportare nei termini della legalità” un procedimento, quello consequenziale alle dichiarazioni di F.F., che, all’epoca delle divulgazioni oggetto di giudizio, per quanto rappresentatogli da C.C., si trovava in una fase di ingiustificato stallo, come comprovato dalle considerazioni esposte nella sentenza n. 3178 del 2024 dal Tribunale di Brescia nell’ambito del procedimento Eni/Nigeria/Shell, la cui motivazione, depositata nelle more, è stata parimenti allegata dalla difesa.
Si assume, al riguardo, la manifesta illogicità della decisione impugnata in punto di riscontrata sussistenza del dolo o, comunque, di ingiustificata esclusione della applicabilità alla specie della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., quantomeno in termini di putativa sussistenza dell’obbligo di adempiere un dovere.
Motivi della decisione
1. Lo scrutinio degli articolati motivi di impugnazione prospettati dalla difesa presuppone la necessaria descrizione delle situazioni in fatto, cristallizzate dalle due sentenze di merito e non contrastate dal ricorso, che, ad avviso di questa Corte, assumono una dirimente centralità nel definire la vicenda a giudizio.
Ciò anche al fine di puntualizzare l’indifferenza, ai fini della decisione che occupa, di alcune tematiche il cui contenuto, per quanto apprezzato dai Giudici del merito, non incide sulla verifica di legittimità devoluta a questa Corte, così da rendere altrettanto ultronee le ragioni di critica mosse, su tali punti, nel ricorso.
2. In linea con tale premessa, giova da subito mettere in evidenza che le dichiarazioni di F.F., oggetto della divulgazione operata da C.C. a A.A. nell’aprile del 2020, furono rese a far tempo dal dicembre 2019 nel corso di alcuni interrogatori che vedevano il dichiarante indagato in un procedimento iscritto presso la Procura milanese.
Tali dichiarazioni riguardavano, pacificamente, ipotesi di reato estranee ai fatti oggetto dell’indagine che vedeva F.F. in quella sede indagato; vedevano il dichiarante possibile protagonista delle condotte descritte; inerivano alla riferita sussistenza di una associazione segreta che, tra le altre cose, avrebbe influenzato l’azione del Consiglio Superiore della Magistratura all’epoca della consiliatura precedente a quella insediata al momento delle propalazioni, pur coinvolgendo, tra gli altri, due componenti del Consiglio in carica, R.R. e B.B.; furono rese da F.F. ai due Magistrati del P.M. coassegnatari della relativa indagine (S.S. e, per l’appunto, C.C.), i quali procedettero contestualmente a segretare i relativi verbali ai sensi dell’art. 329, comma 3, lettera a), cod. proc. pen., considerato il pacifico coinvolgimento di terze persone diverse dal dichiarante.
2.1. All’iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. della notizia di reato consequenziale alle dette dichiarazioni si pervenne da parte della Procura milanese il 12 maggio del 2020. Il reato ipotizzato riguardava la configurabilità di una associazione segreta punita ai sensi della legge n. 17 del 1982 e, pacificamente, tra i soggetti iscritti, risultava F.F. ma non erano menzionati Magistrati né, in particolare, i due citati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura: circostanza, questa, che ebbe a connotare l’indagine in questione anche dopo la trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e sino alla disposta archiviazione.
2.2. Si può anche dare probatoriamente per incontroverso, per il concordante confluire sul punto delle relative emergenze probatorie, che fu C.C. a voler contattare A.A., che all’epoca non conosceva; e che la scaturigine di tale incontro trovava giustificazione, secondo la prospettazione offerta da entrambi i concorrenti, nelle resistenze che, ad avviso di C.C., l’ufficio di appartenenza e, in particolare, il Procuratore della Repubblica dell’epoca, la co-assegnataria dell’indagine nel corso della quale F.F. venne sentito e un altro Sostituto procuratore, titolare di un procedimento rispetto al quale dette dichiarazioni potevano rilevare, opponevano alla immediata iscrizione delle possibili situazioni di reato emergenti da tali propalazioni.
2.3. È, infine, pacifico che C.C. ebbe a manifestare a A.A. le sue perplessità rispetto alla opportunità di una tale divulgazione in ragione del segreto che copriva le notizie che intendeva rivelargli; e che l’odierno ricorrente ebbe a rassicurarlo, sotto tale profilo, sulla base di una indicazione di principio più volte ribadita anche nel corso del presente processo, quella della non opponibilità del segreto investigativo al Consiglio Superiore della Magistratura e, per esso, ai suoi componenti, tra i quali, per l’appunto, il A.A..
Rassicurazione, questa, che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che ebbe a giudicare separatamente C.C. in esito al rito abbreviato da questi scelto, sarebbe stata alla base dell’errore incolpevole sul fatto ex art. 47 cod. pen. in forza del quale il concorrente, per l’affidamento riposto nella qualificata professionalità di A.A., è stato mandato assolto in ragione della ritenuta insussistenza del dolo, con decisione poi confermata in appello.
3. Ciò premesso, ritiene la Corte che nel valutare la tenuta della decisione impugnata riguardo al giudizio di responsabilità ascritto al ricorrente per le condotte di rivelazione allo stesso addebitate, occorra distinguere tra quelle descritte dal primo capoverso del capo di imputazione, legate alla divulgazione resa da C.C. a A.A. nell’aprile del 2020; e quelle realizzate da A.A. dopo aver acquisito da C.C. la notizia e i verbali coperti da segreto riproducenti le dichiarazioni di F.F., riportandone il contenuto e consegnando copia dei verbali dei citati interrogatori ad alcuni componenti del Consiglio Superiore dalla Magistratura, nonché alle sue collaboratrici amministrative.
La sentenza impugnata, infatti, non merita censure limitatamente alla prima delle due parti di condotta sopra rassegnate.
4. In relazione alla prima condotta di rivelazione descritta dall’imputazione, nella conforme valutazione dei Giudici del merito, il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell’ipotizzata violazione dell’art. 326, comma 1, cod. pen. perché sarebbe stato concorrente, quale extraneus, di C.C., soggetto tenuto al segreto.
Tanto, per averne decisamente supportato la condotta materiale a fronte dei dubbi paventati dal concorrente qualificato al momento della loro interlocuzione, proprio con riguardo alla presenza del segreto che copriva il dato di indagine da rivelare: in particolare, per quanto già evidenziato, il ricorrente avrebbe rassicurato l’intraneus in ordine alla non opponibilità del segreto investigativo allo stesso in quanto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Condotta, questa, adeguatamente cristallizzata dalle emergenze in fatto acquisite, rimaste estranee ai rilievi prospettati dal ricorso, per quanto già rassegnato; e che si pone in linea con le coordinate interpretative dettate da questa Corte quanto agli elementi costitutivi propri della fattispecie a giudizio, che, come è noto, punisce unicamente il propalatore qualificato (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) della notizia riservata e non il soggetto che la riceve, salvo che quest’ultimo non si sia limitato passivamente a riceverla ma abbia, con il proprio contegno, contribuito al disvelamento illecito, istigando, inducendo o comunque supportando l’intraneus nella esecuzione della relativa condotta materiale.
Si è, in particolare, precisato che il contributo morale offerto dal concorrente extraneus, in base all’ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, sottraendosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, cui invece deve uniformarsi la condotta dell’autore dell’illecito e, quindi, del concorrente che esegue l’azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe (in termini, Sezioni Unite n. 420 del 28/11/1981, dep. 1982, Emiliani, Rv. 151619, con indicazioni ribadite nel tempo e, in particolare, da Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Rv. 270546; Sez. 6, n. 7977 del 18/09/2015, Rv. 265752; Sez. 1, n. 27231 del 30/06/2015; Sez. 1, n. 5842 del 17/10/2011, Rv. 249357).
5. Ciò premesso, la difesa, nell’articolato sviluppo dell’argomentare critico sotteso al ricorso, ha messo in gioco temi immediatamente inerenti alla stessa configurabilità in sé del reato, prescindendo dalla specifica posizione del ricorrente; ed ha altresì mosso rilievi in ordine alla correttezza della imputazione mossa a A.A., mai ricondotta, anche nella valutazione di merito resa a sostegno della ritenuta responsabilità, all’ipotesi della ed. autoria mediata prevista dall’art 48 cod. pen., malgrado l’intervenuta assoluzione del concorrente qualificato per la ritenuta assenza del dolo a lui ascrivibile.
Con altre censure, principalmente agganciate a tale ultimo aspetto, si è contestata la responsabilità di A.A. sotto il versante soggettivo, comunque messo in discussione in ragione della rivendicata applicabilità dell’art. 51 cod. pen., quantomeno in termini di putativa sussistenza dell’obbligo di adempiere ad un dovere.
6. Sotto il primo versante, quello inerente alla condotta materiale nel caso tenuta dai concorrenti, si è contestata, anzitutto, la stessa presenza di un segreto da tutelare per la ritenuta abnormità o, comunque, per la illegittimità – in ragione di un asserito difetto di motivazione – della segretazione apposta sui verbali contenenti le dichiarazioni di F.F., disvelate da C.C.
L’assunto è manifestamente infondato, a prescindere dalla stessa possibilità di sindacare la legittimità della segretazione apposta in applicazione della regola stabilita dall’art. 329 cod. proc. pen. nel contesto afferente al giudizio di responsabilità correlato alla violazione del segreto investigativo.
La rivelazione di C.C. ha infatti riguardato il contenuto di dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese – nel corso di una attività di indagine già in corso – da un indagato in sede di interrogatorio innanzi al Pubblico Ministero procedente.
A differenza di quanto sostenuto con il ricorso, non rileva che le propalazioni in questione inerissero a fatti estranei alla indagine nel corso della quale furono acquisite, né che le relative notizie di reato non fossero state ancora iscritte alla data della prima condotta a giudizio.
La sede di acquisizione delle relative dichiarazioni, infatti, rendeva le notizie riferite e i relativi atti di verbalizzazione ontologicamente coperti dal segreto investigativo: riguardando anche la posizione di terzi diversi dal dichiarante potenziale imputato, gli stessi furono poi coerentemente segretati dagli inquirenti, ai sensi del primo e del terzo comma dell’art. 329 cit., perché esondanti la posizione del solo dichiarante.
Ciò a meno di non volere ritenere, come sembra sostenere il ricorso, che, nelle more della relativa iscrizione, le dichiarazioni dell’indagato, acquisite in sede di indagine dal Pubblico ministero nel corso di un interrogatorio ma relative a potenziali fatti di reato stranei all’oggetto della stessa, debbano considerarsi liberamente ostensibili: soluzione interpretativa all’evidenza non condivisibile, perché destinata a compromettere radicalmente la ratio e la rituale applicazione della regola sottesa alla stessa possibilità di segretazione sancita dall’art. 329 cod. pen.
La circostanza, infine, che a disvelare la notizia sia stato lo stesso soggetto che nel caso ha contribuito formalmente ad apporre il segreto non solo è del tutto inconferente, ma rafforza il complessivo assetto di responsabilità che si legano alla relativa condotta di disvelamento: il dovere assoluto di riservatezza che nel sistema processuale si lega all’apposizione del segreto investigativo prescinde, all’evidenza, da ogni forma di libera disponibilità dello stesso che non trovi sede nelle dinamiche procedimentali interne all’attività di indagine che lo ha giustificato.
7. La difesa ha inoltre sostenuto, sempre sotto il versante oggettivo, che nel caso di specie C.C. era legittimato a rivelare le notizie in questione a A.A. perché il segreto investigativo doveva ritenersi inopponibile al Consiglio Superiore della Magistratura e, dunque, anche ai singoli Consiglieri.
L’assunto non coglie nel segno, condividendo questa Suprema Corte le ineccepibili considerazioni svolte sul tema dai Giudici del merito.
7.1. In primo luogo, va ribadito un dato essenziale, che peraltro si pone in termini di intima coerenza con le prospettazioni difensive, mettendone tuttavia in luce, al contempo, la intrinseca contraddittorietà logica: le dichiarazioni di F.F., pur potendo riguardare azioni illecite riferibili a Magistrati, non hanno mai visto, al momento della rivelazione di C.C. – giacché non v’era ancora iscrizione – e pur dopo l’iscrizione avvenuta il 12 maggio 2020, la formale presenza di Magistrati soggetti ad indagine in ragione del loro contenuto.
C.C., infatti, nel promuovere l’incontro con A.A., lamentava a monte l’inerzia mostrata dal suo Ufficio rispetto all’esigenza di una pronta iscrizione delle notizie di reato oggetto delle dette propalazioni: il formale coinvolgimento in una indagine di soggetti appartenenti alla Magistratura e, in conseguenza, la stessa possibilità di ritenere prima facie il Consiglio Superiore interessato, nei suoi risvolti istituzionali, alle vicende narrate da F.F., già sul piano logico presupponeva, dunque, uno sviluppo progressivo del relativo incedere procedimentale, non solo inattuale in quel momento – tant’è che se ne lamentava il ritardo – ma anche eventuale, perché rimesso alle discrezionali scelte valutative, anche sul piano soggettivo, degli inquirenti chiamati al relativo incombente.
Scelte non riferibili al solo propalante qualificato.
In altre parole, l’eventuale coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura trovava immediata dipendenza logica nella presenza di attività di indagine svolte nei confronti di Magistrati; e, all’epoca della prima rivelazione – ma, come detto, anche alla ata delle altre condotte descritte dall’imputazione -, non solo non ve ne erano formalmente, ma non era neppure certo che ve ne sarebbero state.
7.2. Piuttosto, proprio le ragioni sottese all’incontro con A.A., puntualmente rassegnate dal concorrente e confermate dal ricorrente, danno conto immediato dell’assoluta distonia logica della scelta, da parte dello C.C., di contattare informalmente A.A. per così veicolare al Consiglio Superiore la tematica sottesa agli ostacoli asseritamente frapposti al rapido incedere delle indagini correlate alle dichiarazioni di F.F.; scelta, questa, decisamente supportata dal comportamento rassicurante sotto tale profilo tenuto dal ricorrente, dall’alto della posizione all’epoca rivestita, oltre che in ragione di una incontroversa autorevolezza acquisita nel tempo grazie al suo percorso professionale.
A fronte del paventato stallo rispetto alla solerte adozione del provvedimento di iscrizione sollecitato da C.C., la via istituzionale da seguire nel definire tale asserita conflittualità interna all’ufficio di provenienza non presentava margini di incertezza forieri di dubbi applicativi, in linea con quanto condivisibilmente rimarcato nelle conformi decisioni dei Giudici del merito.
Anziché portare a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura la vicenda in questione – contattandone un componente, in via tanto informale quanto meramente confidenziale, con modalità all’evidenza poco compatibili con la serietà e delicatezza dei temi in gioco -, C.C. avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello territorialmente competente, chiamato, ex art. 6 D.Lgs. n. 106/2006, a risolvere i contrasti inerenti all’esercizio dell’azione penale e all’iscrizione delle notizie di reato.
7.3. Del resto, che fosse questa, senza incertezza di sorta, sul piano ordinamentale, la corretta via istituzionale da seguire, è aspetto che lo stesso ricorrente ha mostrato non solo di conoscere, ma anche di condividere, affermando, nel corso del suo esame dibattimentale, che tale modalità di azione non venne in concreto privilegiata a causa della ridotta affidabilità della persona che all’epoca temporaneamente rappresentava l’Ufficio della Procura Generale milanese (si veda la sentenza impugnata, pagina 106).
Dato, questo, mai sottoposto a revisione critica da parte del ricorso; e che, di converso, assume una assorbente decisività nell’ottica della confermata affermazione di responsabilità, anche sotto il versante soggettivo, per quel che più avanti si dirà.
7.4. Anche a voler ritenere, come in tesi prospettato dal ricorrente, che le dichiarazioni di F.F. – nella parte in cui riguardavano il funzionamento dell’organo di autogoverno della Magistratura nella precedente consiliatura, in tesi influenzato dalla loggia segreta descritta dal predetto dichiarante – potessero in qualche modo investire le competenze ascritte al Consiglio Superiore, prescindendo dal formale coinvolgimento di Magistrati nella relativa indagine, ciò malgrado non si perviene comunque ad una conclusione diversa: una tale prospettiva, infatti, non consentiva e non consente comunque di ritenere le esigenze sottese al segreto investigativo, apposto sui relativi verbali di interrogatorio, recessive rispetto a quelle di acquisizione “consiliare” dei relativi dati conoscitivi, per l’evidente erroneità della ricostruzione della pertinente normativa di riferimento.
A fronte della segretazione imposta dalla disciplina normativa primaria (nel caso in esame dall’art. 329 cit.), si è puntualmente evidenziato nella impugnata sentenza che le fonti normative secondarie destinate ad incidere sul tema (ossia le circolari consiliari deliberate tra il 1994 e il 1995, ivi citate alla pagina 101) rendevano e rendono meramente facoltativo e, dunque, tutt’altro che automatico l’accesso del Consiglio Superiore della Magistratura ad atti coperti dal segreto investigativo, legati a notizie di reato o, comunque, a fatti o circostanze che possano lambire le competenze dell’Ufficio giudiziario procedente: quest’ultimo infatti (in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello o del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in forza dell’ultima delle circolari citate, quella del 17 maggio 1995) potrebbe sempre rifiutarne l’ostensione, omettendo la trasmissione e giustificando le ragioni di opportunità di una siffatta scelta.
Il che, ancora una volta, rendeva manifestamente inconferente la soluzione privilegiata dai due concorrenti, vieppiù se filtrata alla luce della imprescindibile comparazione tra la delicatezza della materia gestita, per la rilevante connotazione pubblicistica delle ragioni sottese all’apposizione del segreto investigativo, e la chiarezza del percorso istituzionale predisposto dall’ordinamento nel definire la situazione di difficoltà in cui, a suo dire, si era trovato C.C. nel gestire l’attività di indagine consequenziale alle dichiarazioni rese da F.F.
8. V’è poi da osservare che il ricorrente ha sostenuto la non configurabilità del reato in questione per la non riscontrata presenza di un pericolo effettivo consequenziale alla condotta posta in essere da C.C. con il concorso del ricorrente, giacché la rivelazione della notizia, più che nuocere all’indagine, avrebbe consentito di ricondurla nei binari della legalità. Tesi, questa, che poi è stata estesa anche alle ulteriori condotte di divulgazione oggetto del tema d’accusa formulato nell’imputazione.
8.1. L’assunto è manifestamente infondato.
In caso di violazione del segreto investigativo, l’onere di riservatezza della notizia risulta imposto ex lege in ragione della previsione di cui all’art. 329 cit. a prescindere dalla concreta incidenza che abbia assunto il suo disvelamento rispetto all’ordinario e utile sviluppo dell’indagine. Va infatti ribadito, secondo un orientamento consolidato di questa Suprema Corte, incidentalmente valorizzato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4964 del 27/10/2011, dep. 2012 (e da ultimo ribadito da questa Sezione con la sentenza n. 4194 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282882), il principio secondo cui, quando è la legge a prevedere l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l’esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l’esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell’obbligo del segreto.
8.2. Dalla rilevata offensività in sé della condotta di rivelazione consegue, quale logico corollario, l’indifferenza di qualsivoglia indagine in fatto diretta ad accertare la positiva incidenza della rivelazione sulla scorta di quanto dal ricorrente evocato sotto tale profilo.
Ci si riferisce, in particolare, alle argomentazioni oggetto del secondo motivo di ricorso, quanto al rilievo da ascrivere, in tesi, al colloquio avuto dall’imputato con il Procuratore Generale della Cassazione riguardo alle notizie acquisite da C.C.; e all’incidenza che tale interlocuzione avrebbe assunto rispetto ai contatti intrattenuti tra il Procuratore Generale della Cassazione e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dai quali, secondo il ricorrente, sarebbe scaturita l’iscrizione ex art 335 cod. proc. pen., in effetti intervenuta nel maggio del 2020.
8.3. La su richiamata impostazione, diretta a rimarcare la netta distanza tra l’asserita volontà dei concorrenti di sollecitare una pronta iscrizione delle notizie derivanti dalle dichiarazioni di F.F. e la strada, ciò malgrado, di fatto comunemente seguita, palesemente distonica rispetto a tale affermato obiettivo, rende parimenti superflue le valutazioni di fatto, in più occasioni sollecitate dalla difesa nei diversi scritti depositati nel corso del presente giudizio, in ordine alla rimarcata necessità di procedere quanto più celermente all’adempimento di tale incombente procedurale, attesa l’evidente inconferenza funzionale del preteso coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto a tale risultato.
9. Né merita censure la scelta dei Giudici del merito di inquadrare comunque la responsabilità del ricorrente nello schema del contributo concorsuale offerto alla condotta materiale di disvelamento resa da C.C., in linea con l’imputazione, malgrado il giudicato, per la ritenuta insussistenza del dolo, caduto sull’assoluzione del concorrente, deliberata nell’autonomo giudizio abbreviato svolto nei confronti di quest’ultimo.
9.1. Sostiene la difesa, con i motivi addotti per ottavo e nono, che il concorso prospettato con l’imputazione non poteva più sostenersi giuridicamente una volta assolto C.C. per mancanza di dolo; e che i giudici del merito, in difformità dall’imputazione, avrebbero ricostruito la responsabilità del ricorrente in termini coerenti alla previsione di cui all’art. 48 cod. pen., tuttavia mai contestata, con conseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
9.2. L’assunto è infondato per più ragioni.
9.2.1. Giova premettere che l’utilizzo del verbo indurre – di cui pure si è avvalsa la Corte territoriale nell’apprezzare la condotta del ricorrente- non legittima, per ciò solo, l’idea, prospettata dall’impugnazione, secondo la quale la ricostruzione della relativa responsabilità sarebbe stata effettuata riconducendone la posizione all’ambito dell’autoria mediata di cui all’art. 48 cod. pen., così distanziandosi dall’imputazione.
È vero, piuttosto, il contrario, attesa la specifica presa di posizione assunta sul punto in sentenza (si veda dalla pagina 91) e la coerente assenza di riferimenti argomentativi in ordine a possibili contegni ingannevoli messi in atto dal A.A. nel sostenere l’azione dello C.C.
In questo contesto, l’induzione letteralmente evocata dalla Corte del merito perde i contenuti di tipicità giuridica propri dell’ipotesi di cui all’art. 48 cod. pen., per assumere un portato coerente al suo più ampio significato ordinario, che ben comprende anche le ipotesi di decisiva persuasione che puntualmente si attagliano alla condotta concorsuale nel caso ascritta al ricorrente, in linea con l’imputazione.
9.2.2. Del resto, quali che siano state le ragioni che, all’esito del separato giudizio di merito, hanno portato a ritenere non punibile C.C., attribuendo assorbente decisività alle rassicurazioni ed ai chiarimenti offerti da A.A. rispetto alla non opponibilità del segreto investigativo ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (così da portare nell’area dell’errore incolpevole sul fatto disciplinata dal comma 3 dell’art. 47 cod. pen. la condotta di disvelamento resa dall’intraneus), le stesse, in presenza di una sovrapponibile ricostruzione della vicenda in fatto, non vincolavano le autonome valutazioni di competenza dei Giudici chiamati a verificare la responsabilità dell’extraneus su tali temi.
Se infatti, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, solo una inconciliabile ricostruzione del fatto storico emersa tra i due giudizi autonomamente resi nei confronti di soggetti concorrenti nello stesso reato può, da un punto di vista statico, ritenersi tale da legittimare il rimedio della revisione – di contro escluso nel caso di un diverso epilogo conseguenziale ad una difforme valutazione di quei fatti, nelle sue derive logiche e giuridiche (ex multis, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317, con i conformi arresti ivi riportati) – alla stessa stregua, da un punto di vista dinamico, le autonome scelte valutative rese nel separato giudizio di merito svolto nei confronti del concorrente lasciano intatto il libero convincimento del giudice chiamato a decidere della posizione del concorrente, non ancora definitivamente giudicato.
Entro tale necessaria prospettiva ermeneutica, non meritano censure le valutazioni congruamente operate dai Giudici del merito, coerenti alla situazione in fatto emersa dagli atti, destinata a dare conto di una condotta illecita che ha trovato fonte nell’autonoma iniziativa di C.C.; e che, a fronte dei dubbi ciò malgrado paventati da quest’ultimo, ha trovato un supporto di rilievo nell’opera di convincimento, di sostanziale persuasione e di adeguato consolidamento dell’altrui agire operata dal ricorrente sul concorrente, dissolvendone le incertezze dall’alto della sua indiscussa autorevolezza professionale e in considerazione dello specifico ruolo istituzionale all’epoca rivestito.
9.2.3. In altre parole, la scaturigine del contatto, le modalità dell’interlocuzione tra i due protagonisti, ma anche la qualità soggettiva del concorrente intraneo e la sua possibilità di affrontare e risolvere consapevolmente il tema da affrontare e superare nel relativo contesto fattuale, hanno condivisibilmente consentito ai Giudici del merito, nell’ambito dell’autonoma valutazione di loro competenza, di escludere, nella specie, la presenza dell’inganno induttivo tipicamente proprio dell’autoria mediata; e, al contempo, di confermare il tenore dell’imputazione originaria, riconducendo all’area concorsuale la condotta dell’extraneus, in ciò favoriti, per quanto già evidenziato, dalla atipicità di contenuti del contributo in tal senso configurabile.
10. Anche la valutazione resa nel ribadire il dolo del ricorrente con riferimento al concorso nella condotta di rivelazione originariamente resa da C.C. non merita censure, dovendosi escludere la fondatezza dei rilievi prospettati sia nel rivendicare la presenza di un errore scusabile ex art. 47 cod. pen., riferibile alla posizione di A.A. alla stessa stregua di quanto già affermato per C.C. nell’autonomo giudizio che ha riguardato l’intraneus; sia riguardo alla possibilità di ritenere non punibile nel caso la relativa condotta, perché resa in adempimento di un dovere, quantomeno ritenuto in via meramente putativa.
10.1. Giova nuovamente rimarcare, sotto tale profilo, che, secondo quanto continuativamente affermato dal ricorrente e ribadito negli atti difensivi, l’intenzione da lui perseguita non era altra se non quella di riportare il procedimento all’interno dei “binari della legalità”.
Proprio muovendo da tale ribadita chiave di lettura, tuttavia, emerge in modo incontrovertibile la marcata distonia logica che connota la condotta a giudizio, là dove si consideri che il ricorrente ha espressamente confermato di aver avuto piena contezza che la strada da intraprendere, più coerente al detto proposito, fosse un’altra rispetto a quella poi concretamente seguita (anziché investire il Consiglio Superiore della Magistratura, sollecitare C.C. ad interfacciarsi con il Procuratore Generale della Corte di appello di Milano, suo referente istituzionale quanto all’affidamento della tematica sottopostagli); ciò, tuttavia, non senza precisare di non averla suggerita ali’intraneus per ragioni all’evidenza inconsistenti sul piano della rilevanza giuridica (la modesta fiducia serbata nella persona che all’epoca reggeva il detto Ufficio giudiziario).
10.2. Tale consapevolezza assume, per quanto già anticipato, un portato di assorbente decisività.
10.2.1. Per un verso esclude a monte la possibilità di ritenere obbligata, anche nell’intimo, seppur erroneo, convincimento dell’imputato, la condotta delittuosa messa in atto, così da neutralizzare, senza incertezze, la rivendicata applicabilità dell’art. 51 cod. pen., atteso che, per una scelta del tutto personale e marcatamente arbitraria, il ricorrente – nel manifestare la sua opinione all’intraneus, determinante nel quadro della rivelazione del segreto da questi operata – ha ritenuto di trascurare volutamente quella ritualmente prevista dall’ordinamento per ovviare al problema che si intendeva risolvere.
10.2.2. Per altro verso, costituisce un ulteriore tassello a conferma della piena condivisibilità della valutazione operata dai Giudici del merito nell’escludere, quantomeno con riguardo al A.A., che la relativa condotta potesse ritenersi ammantata da una erronea comprensione del dato normativo di riferimento, tale da giustificare l’applicabilità dell’art. 47, comma 3, cod. pen.
La consapevolezza del corretto percorso istituzionale da suggerire a C.C. per superare la situazione di stallo che questi ebbe a rappresentargli prima di procedere alla rivelazione del segreto; la cautela necessariamente imposta dalla presenza di una segretazione imposta ex lege; il contenuto normativo, di non particolare complessità, della disciplina regolamentare dettata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura quanto alle modalità di gestione di vicende di interesse del detto organo coperte dal sequestro investigativo, tutt’altro che rare, costituiscono elementi che, partitamente e globalmente vagliati, danno piena ragione giustificativa della correttezza della decisione sul punto assunta dai Giudici del merito.
Sono, quelli or ora indicati, tutti argomenti che, letti alla luce dello spessore professionale del ricorrente e delle sue specifiche competenze acquisite nel tempo anche sul piano ordinamentale proprio in ragione della carica rivestita all’epoca dei fatti, del tutto coerentemente sono stati apprezzati a sostegno della ritenuta insussistenza di un errore sul fatto.
10.3. Piuttosto, del tutto coerentemente sì è ritenuto, dal parte dei Giudici del merito, che la condotta materiale del ricorrente ben si attagliava al dolo generico che caratterizza la fattispecie incriminatrice in disamina, perché destinata a dare conto che nel caso – con il decisivo contributo del ricorrente – è stato consapevolmente attivato, per ragioni di evidente gratuità rispetto all’importanza dei temi in gioco (la sfiducia soggettivamente riposta nella persona preposta alla risoluzione della problematiche che entrambi gli imputati volevano risolvere), un percorso alternativo per forza di cose destinato a mettere in pericolo la riservatezza della notizia coperta dal segreto investigativo; e ciò, ancor più considerando il metodo evocato da C.C. e validato da A.A. nel portare a conoscenza della vicenda il Consiglio Superiore della Magistratura, compulsato per il tramite di una informale, confidenziale e non consentita consegna ad uno dei suoi componenti di atti processuali coperti da segreto investigativo.
10.4. Le superiori considerazioni rendono evidentemente recessive le criticità sul tema prospettate nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Del resto, l’assenza di un movente, di una giustificazione per la quale il ricorrente ebbe a corroborare l’idea del concorrente di privilegiare una soluzione illecita anziché quella favorita dalla immediatezza della situazione prospettatagli da C.C., a fronte di una situazione personale (quella del suo prossimo collocamento a riposo quale terminale di una carriera certamente specchiata) che rendeva poco comprensibile una siffatta volontà criminale, è un aspetto che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e, in più occasioni, nel corpo dei motivi aggiunti e delle memorie depositate, non assume alcuna incidenza, anche sul piano della tenuta logica, ai fini della pacifica sussistenza del dolo generico, nei termini richiesti dalla fattispecie che occupa, coerentemente motivati nella impugnata sentenza sulla base delle argomentazioni dianzi esposte.
11. Né, infine, la responsabilità del ricorrente può ritenersi preclusa dalla natura del reato in contestazione alla luce della intervenuta esclusione del dolo in capo ali’intraneus, autonomamente decretata dalla sentenza di assoluzione di C.C.
Ad avviso della difesa, con argomentazioni meglio definite nel corso della discussione orale, la rivelazione punita ai sensi dell’art. 326 cod. pen. integra un reato proprio esclusivo in cui la dimensione lesiva del fatto sanzionato risulta inscindibilmente correlata alla violazione di un obbligo realizzata abusando delle funzioni o dei poteri da parte dell’autore qualificato.
In siffatti casi, l’abuso, anche nelle sue componenti soggettive, sarebbe espressione di un disvalore che si riflette sulla tipicità della condotta: mancando il dolo dell’intraneus, verrebbe così messa in discussione la stessa tipicità dell’agire illecito descritto dalla fattispecie, così da rendere evanescente il contributo del concorrente extraneus.
Tale assunto non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
11.1. In primo luogo, per ragioni di ordine processuale, che contribuiscono a rendere indifferente il rilievo.
La ricostruzione dogmatica privilegiata dall’assunto difensivo, ove integralmente condivisa, andrebbe comunque inquadrata e letta, nelle sue ricadute effettuali, alla luce della situazione processuale che ha dato luogo alle due diverse decisioni rese nella specie riguardo alle posizioni dei due concorrenti.
A fronte della facoltà, garantita dall’ordinamento ai concorrenti, di farsi giudicare separatamente, accedendo a riti diversi e sottoponendosi a decisioni non congiunte, suscettibili di un potenziale conflitto, l’idea dell’ assorbente incidenza assunta, per i reati quale quello in esame, dall’atteggiamento volitivo dell’intraneus rispetto alla complessiva tipicità del fatto, tale da poter incidere anche sulla responsabilità del concorrente extraneus, ove condivisa, non potrebbe comunque mettere in discussione, né tanto meno eliminare, la possibilità, da parte delle rispettive autorità decidenti, di apprezzare in modo autonomo, ma altrettanto unitario e complessivo, la vicenda a giudizio, considerando dunque, seppur incidentalmente, anche la posizione del concorrente non immediatamente coinvolto nel processo di relativa pertinenza.
In altre parole, proprio le connotazioni della fattispecie in questione, se valorizzate nei termini della descritta ricostruzione dogmatica, imporrebbero di ampliare il perimetro della cognizione rimessa al giudice chiamato a vagliare la posizione del concorrente extraneus: la dominante rilevanza ascritta, in siffatte fattispecie, anche ai profili soggettivi e non solo materiali della condotta dell’intraneus nel definire la tipicità del fatto cui dovrebbe accedere il contributo del concorrente non qualificato, non potrebbe che legittimare, nel processo che riguarda esclusivamente quest’ultimo, uno scrutinio incidentale dei tratti identificativi della condotta del concorrente intraneo, anche nei suoi risvolti soggettivi, da apprezzare in via strumentale ed esclusivamente servente alla sola verifica della responsabilità dell’extraneus.
Ragionando diversamente, in siffatte ipotesi, il giudizio relativo all’intraneus o, per meglio dire, le correlate valutazioni giuridiche poste a fondamento della decisione da assumere in merito alla rilevanza di detta posizione, finirebbero per avere sempre una potenziale prevalenza vincolante su quelle riguardanti il processo svolto a carico del concorrente extraneus, con evidenti profili di irragionevolezza di ordine logico-sistematico.
I relativi spazi decisori finirebbero, infatti, per mantenere una autonomia solo apparente, con grave compromissione del libero convincimento del giudice che sta alla base della scelta di sistema sottesa alla possibilità di accesso alle diverse vie di definizione processuale della medesima vicenda in fatto, ove ascritta al concorso di più persone. Il tutto mettendo in discussione, in siffatte ipotesi, i già richiamati principi espressi da questa Corte nel rilevare l’insussistenza di una inconciliabilità tra giudicati, là dove il conflitto tra le decisioni finisca per cadere non sulla ricostruzione del fatto, ma sulle valutazioni che allo stesso si correlano.
Ciò premesso, vale evidenziare, nel caso, che la Corte del merito, seppur incidentalmente (si veda la pagina 105 della sentenza impugnata), ha sinteticamente, ma ragionevolmente sottolineato la non sostenibilità della conclusione resa nel separato giudizio di merito, diretta a valorizzare, in termini di assorbente decisività, il parere reso da A.A. rispetto all’atteggiamento volitivo assunto da C.C.; il tutto a fronte della immediatezza offerta dalla soluzione ritualmente apprestata dall’ordinamento al problema che quest’ultimo stava affrontando, non bisognevole di grandi approfondimenti o di conoscenze imposte da specifiche competenze professionali diverse da quelle ordinariamente proprie del detto concorrente.
Per quanto causalmente in grado di incidere sul proposito criminoso dell’intraneus, rendendolo definitivo, il contributo concorsuale offerto da A.A., dunque, non avrebbe assunto, nel caso, una incidenza tale da neutralizzare a monte l’elemento soggettivo riferibile a C.C., lasciandone inalterata la responsabilità, non diversamente da quanto affermato per il concorrente non qualificato.
Ne consegue che, anche ad accogliere l’impostazione dogmatica prospettata dalla difesa, la stessa finirebbe per non assumere concreta incidenza nel caso, una volta che si ritenga di poter ricostruire in termini identici, per entrambi gli imputati, il giudizio da rendere sul dolo, anche se in termini di strumentalità strettamente funzionale alla valutazione della posizione del solo extraneus, immediatamente sottoposto all’autonomo giudizio devoluto nel caso alla Corte.
11.2. Ma l’assunto difensivo non convince neppure in tesi, perché immediatamente smentito dalla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema.
Si suole infatti affermare che, in tema di concorso di persone nel reato, l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo in capo al concorrente “intraneo” nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente “estraneo”, che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all’art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo il concorrente “intraneo” e non sia quindi estensibile, come deve dirsi nella specie, alla posizione dell’extraneus (Sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Rv. 272081); e ciò anche con riguardo all’ipotesi di reato in contestazione (Sez. 2, n. 219 del 17/10/2018, dep. 2019, Rv. 274461) o ad altre fattispecie comunque connotate dal rilievo assunto, sul piano della tipicità della condotta, dall’abuso dei poteri o dei doveri gravanti sull’intraneus (in tema di abuso d’ufficio, Sez. 6, n. 36166 del 18/06/2004, Rv. 229948).
Scelta interpretativa, questa, il cui fondamento riposa su diversi profili di ordine logico-sistematico, indicativi della irrilevanza della non punibilità, per la non imputabilità ma anche per la mancanza di colpevolezza, di uno dei concorrenti (segnatamente dagli artt. 46 comma 2, 111, 112, ultimo comma, 119 cod. pen., oltre che dall’art. 48 cod. pen., là dove si intenda mantenere la relativa figura all’interno della fattispecie concorsuale che ne informa il portato sul piano materiale). E che si sviluppa ammettendo che dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti, aventi in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma suscettibili di autonoma considerazione riguardo all’atteggiamento psichico di ciascuno dei compartecipi (considerazioni esposte in motivazione dalla sentenza n. 2157 del 17 gennaio 2019 della Sez. 6, di recente riprese dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta); e ciò alla luce della assorbente centralità comunque da assegnare, anche nei reati propri, al fatto tipico principale riferito normativamente all’autore qualificato, considerato nella sua oggettiva materialità e prescindendo dalla colpevolezza dell’intraneus, così da recuperare, all’area della responsabilità penale, tutte le condotte partecipative atipiche che a quel fatto accedono e che si risolvono in una indebita strumentalizzazione della posizione del concorrente qualificato.
Da qui la definitiva conferma della responsabilità dell’imputato per la condotta di rivelazione realizzata in concorso con C.C., per come descritta nel primo capoverso della relativa imputazione.
12. Ad una soluzione diversa deve giungersi con riferimento alle altre condotte di divulgazione messe in luce dall’imputazione, materialmente riferite ad una serie di comportamenti esclusivamente ascritti all’odierno ricorrente.
12.1. Riguardo a tali condotte il reato contestato a A.A. risulta configurato facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, in tema di rivelazione di segreti d’ufficio, il soggetto ‘estraneo’ risponde del reato a titolo di concorso con l’autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore (Sez. 5, n. 1957 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280413; Sez. 6, n. 42109 del 14/10/2009, Rv. 245021; Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Rv. 264782; Sez. 6, n. 15489 del 26/02/2004, Rv. 229344).
12.2. Siffatta conclusione non può essere accolta per più ragioni.
12.2.1. In primo luogo, perché l’orientamento interpretativo evocato dalla Corte del merito inquadra l’ipotesi di responsabilità in questione sempre nell’ottica della responsabilità concorsuale, ricostruita guardando alla figura del propalante qualificato.
Nel caso, tuttavia, l’addebito non risulta sia mai stato mosso a C.C.. E, del resto, che si tratti di comportamenti estranei alla prima condotta di rivelazione è dato che, per un verso, trova conferma nella contestata e ritenuta continuazione tra più fatti, per forza di cose, dunque, diversi tra loro; per altro verso, è aspetto incontrovertibilmente attestato, come puntualmente rimarcato dalla difesa con i motivi aggiunti, nel tenore letterale dell’imputazione, ove risultano contestate singole ipotesi di rivelazione costruite facendo esclusivamente leva sulla qualifica soggettiva di A.A. (viene richiamata la sua qualità di componente del Consiglio Superiore della Magistratura) e sulla violazione dei doveri inerenti a quella funzione o comunque sull’abuso della relativa qualità.
Da qui la manifesta inconferenza del riferimento alla citata giurisprudenza di legittimità, che comunque muove dal diverso presupposto del coinvolgimento nel fatto del soggetto qualificato tenuto al segreto, coinvolto nella rivelazione originaria.
12.2.2. Del resto, anche a voler riportare le condotte in questione all’ambito proprio della prima rivelazione, la lettura interpretativa accolta da questa Corte con gli arresti sopra richiamati deve comunque ritenersi non pienamente condivisibile, là dove rischia di creare talune criticità in punto di tassatività della relativa fattispecie.
Ribadito che la fattispecie in questione punisce unicamente il propalatore (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) della notizia riservata e non il soggetto che la riceve, quest’ultimo risponde, come già evidenziato, solo se, invece di limitarsi a ricevere la notizia, abbia influito sulla scelta del pubblico ufficiale di operare la rivelazione.
Tale rigorosa esegesi dei limiti di applicabilità della norma suggerisce di non dare continuità alle opzioni ermeneutiche basate sulla automatica punibilità di colui che abbia ricevuto la notizia ove in seguito la riveli a terzi, sempre che la notizia stessa abbia conservato il suo carattere segreto: in siffatti casi la punibilità dell’extraneus finisce per costituire un’indebita estensione dell’ambito di operatività della previsione penale, che, come tale, si pone in palese violazione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. e di tassatività della previsione incriminatrice.
Una cosa è, infatti, evidenziare sul piano probatorio la rilevanza di tale successivo segmento di condotta, costituente post factum non punibile, qualora l’extraneus si sia limitato a concorrere nella rivelazione del segreto da parte dell’/’ntraneus; altra cosa è “affermarne la rilevanza penalistica ex se in contrasto con la corretta delimitazione dell’ambito di operatività della figura di reato in esame” (in termini, pedissequamente condivisi, in motivazione, Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018).
12.3. Le su esposte considerazioni danno conto dei vizi che inficiano la decisione impugnata in parte qua.
12.3.1. Le condotte di rivelazione materialmente realizzate da A.A. dopo aver ricevuto la notizia coperta da segreto investigativo da C.C., se ricondotte al concorso in tale prima divulgazione illecita, come hanno mostrato di ritenere, sul piano della relativa giustificazione logico-giuridica, i Giudici del merito, non sarebbero punibili, per quanto già detto.
12.3.2. Di contro, la sentenza impugnata si mostra evidentemente deficitaria sul piano delle relative valutazioni argomentative, laddove, in linea con la struttura e l’oggetto dell’imputazione, le medesime condotte vengano considerate, come necessario, in termini di piena autonomia rispetto alla rivelazione resa da C.C., perché da ricostruire ed esaminare guardando all’obbligo di mantenere il segreto gravante su A.A., alla luce del suo specifico ruolo istituzionale e dei doveri di riservatezza imposti dalla relativa posizione qualificata.
Aspetti, questi, integralmente pretermessi dalla Corte del merito, perché erroneamente apprezzati facendo esclusivamente riferimento alla posizione del coimputato, eccentrica rispetto alla contestazione in questione. E che invece, in linea con l’imputazione, andavano adeguatamente scrutinati giacché, nel caso, la peculiare scaturigine che ebbe a giustificare la conoscenza della notizia (il concorso nella condotta illecita di rivelazione resa da C.C.) non poteva ritenersi ostativa alla configurabilità di successive e autonome condotte di divulgazione illecite sanzionate ex art. 326 cod. pen., atteso che tale fattispecie deve ritenersi integrata anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell’ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l’interessato, per le funzioni esercitate, avesse l’obbligo di impedirne l’ulteriore diffusione (Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016,Rv. 266321;Sez. 6, n. 49600 del 19/11/2015, Rv. 26 5698; Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004, dep. 2005, Rv. 231443).
13. Sotto questo versante si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, perché sulla base delle emergenze in fatto già acquisite e uniformandosi alle indicazioni di principio rese con le presenti statuizioni decisorie, in linea con il tenore dell’imputazione, rinnovi il giudizio di merito verificando nuovamente la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell’imputato per le divulgazioni successive al concorso nella rivelazione di C.C.: divulgazioni verificatesi nella sua qualità di soggetto tenuto al segreto perché componente del Consiglio Superiore della Magistratura e, dunque, valutando le relative condotte in considerazione degli obblighi specificamente derivanti da tale funzione istituzionale.
Laddove la nuova verifica di merito non porti ad una conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato per tali condotte, sarà compito della Corte territoriale rideterminare la pena da irrogare alla luce della già affermata definitività del giudizio di responsabilità per il concorso nella rivelazione operata da C.C.
14. L’annullamento determina, infine, l’assorbimento, allo stato, di tutti gli ulteriori rilievi prospettati dal ricorso in ordine alle condotte successive alla divulgazione materialmente resa da C.C., comprese quelle involgenti la posizione della parte civile, in quanto essenzialmente correlate alla rivalutazione delle condotte per le quali occorre rinnovare la verifica di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di rivelazione del segreto a terzi contestate nel secondo capoverso del capo b) e rinvia per nuovo giudizio su tali condotte ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la responsabilità in ordine alle condotte oggetto del primo capoverso del capo b).
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2025.