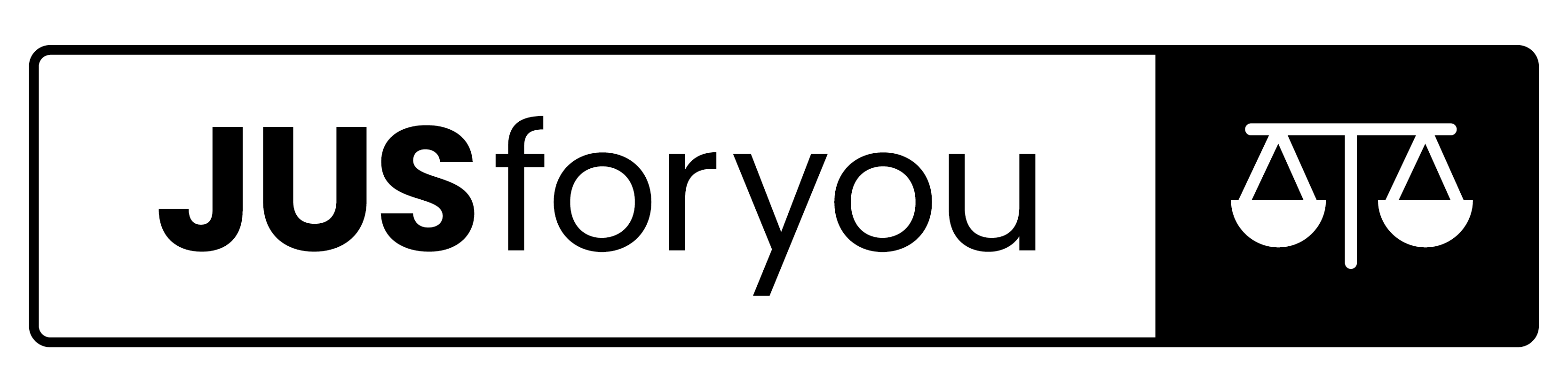Cass. Sez. III, ord. 29 ottobre 2024, n. 27927
La giurisprudenza della Cassazione, aderendo ad antica dottrina, distingue due tipi di questioni pregiudiziali:
a) la questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale), consistente in circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa; ad es., per stabilire se è fondata la domanda di risoluzione bisogna stabilire se esiste un contratto valido ed efficace;
b) la questione pregiudiziale in senso tecnico (o questione pregiudiziale tout court), la quale ha le seguenti caratteristiche:
-) consiste in circostanze distinte ed indipendenti dal fatto costitutivo della domanda;
-) costituisce un presupposto giuridico del fatto costitutivo della domanda;
-) può dar luogo ad un giudizio autonomo;
-) è idonea ad influire su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti.
Si ammette pacificamente che tali questioni possano essere decise con efficacia di giudicato solo in presenza di espressa domanda (così già la sentenza “capofila”, ovvero Sez. U, Sentenza n. 2619 del 05/07/1975, Rv. 376580-01, ove si afferma: “in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere le questioni che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze le quali rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e debbono essere decise necessariamente incidenter tantum e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo di cui, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo ed alla formazione della cosa giudicata”) Tuttavia, la massima appena trascritta, cui la Corte presta formalmente ossequio da cinquant’anni, a causa della sua evidente latitudine si è rivelata inadeguata sul piano pratico e fomite di incertezze. La disamina della giurisprudenza di legittimità rivela, infatti, che, per distinguere le pregiudiziali in senso tecnico da quelle in senso logico, talvolta si privilegia, ma talaltra si svaluta, il requisito della “suscettibilità (della questione pregiudiziale) di dar luogo ad un giudizio autonomo”.
Reputa il Collegio che le oscillazioni sopra evidenziate non scaturiscano dalla inevitabile varietà dei casi concreti, né dalla pur insopprimibile soggettività del giudicante, ma trovino la propria radice prima nella inaffidabilità dei tralatizi criteri di distinzione tra ”pregiudiziale logica” e ”pregiudiziale tecnica”.
Sul piano teorico, è arduo infatti spiegare come una questione possa, nello stesso tempo, essere ”indipendente” dal fatto costitutivo della domanda ma costituirne un ”presupposto giuridico”. Così come, analogamente, è arduo comprendere quali mai potranno essere, in un sistema processuale che ammette l’azione di accertamento, questioni “inidonee a dar luogo ad un autonomo giudizio”.
Sul piano pratico, poi, sono le stesse incertezze in cui si avviluppa la giurisprudenza a dimostrare la scarsa efficienza dei suddetti criteri distintivi, i quali lungi dal costituire un criterio distintivo sicuro, hanno rappresentato nei fatti un argine rotto al torrente delle opinioni ed un volano di contrasti.
Tuttavia, se una regola processuale di fonte giurisprudenziale non è di agevole applicazione; se dà luogo a reiterati contrasti; se non consente la prevedibilità delle decisioni; essa appare di dubbia compatibilità col quadro costituzionale e con i princìpi dell’ordinamento sovranazionale, ben mutato rispetto all’epoca in cui quella regola sorse.
In particolare, i tradizionali criteri distintivi tra pregiudiziale logica e pregiudiziale tecnica sono di dubbia compatibilità sia col principio per cui la legge processuale ”deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti” (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, in causa n. 25358/12, par. 169); sia col principio per il quale gli ”organi nazionali” (tra i quali ovviamente rientrano gli organi giudiziari) dovrebbero “avere orientamenti stabili”, ed esercitare nel corso del tempo i loro poteri in modo da non ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93; nello stesso giudizio, e nello stesso senso, si vedano in particolare le significative conclusioni dell’avvocato generale Georgios Cosmas, in Raccolta, p. 1-572, ma specialmente 581 e ss., par. 24).
È necessario, pertanto, disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite quanto alla questione di giurisdizione del giudice italiano e quanto alla connessa questione di massima di particolare importanza appena descritta.