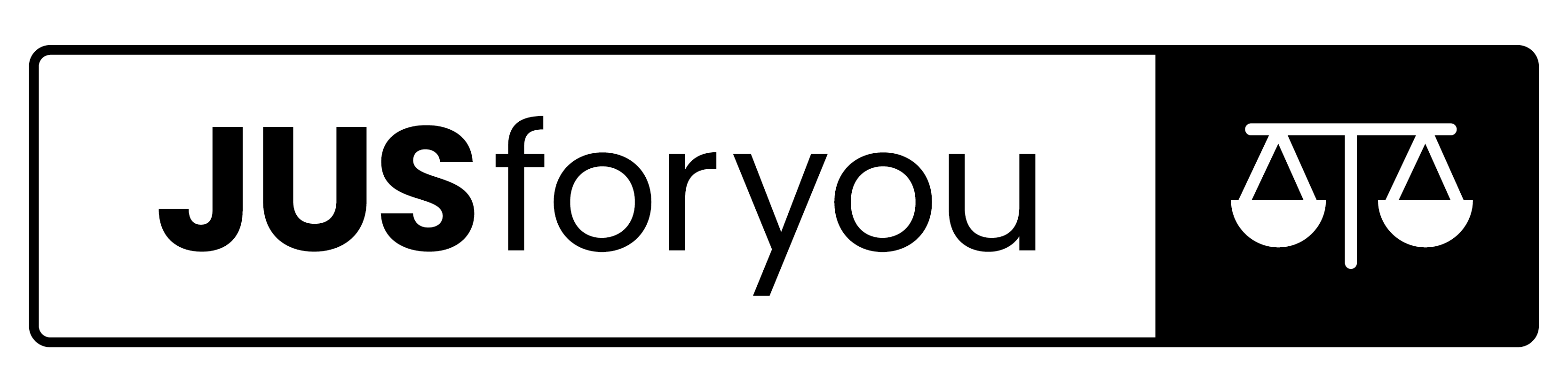La responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende: a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’obbligo informativo in ordine alla prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente si è sottoposto; b) dal verificarsi in conseguenza dell’esecuzione del trattamento – e, quindi, in forza di un rapporto di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume invece alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit informativo, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi nei suoi confronti una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Svolgimento del processo
S.G. convenne, davanti al tribunale di Novara, l’azienda ospedaliera “(omissis) “, struttura ove egli stesso prestava la propria attività in qualità di medico radiologo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni ossee da patologia articolare femorale, e per i gravi postumi delle stesse, subiti quale diretta conseguenza della terapia cortisonica somministratagli per la cura di un’encefalite post-vaccinica e post-influenzale. In particolare, egli non era stato reso edotto dei rischi della terapia allo stesso somministrata che prevedeva, in letteratura, larghi margini di complicanze articolari, quale quella in concreto insorta, non essendo, perciò, stato messo nelle condizioni di prestare il prescritto consenso informato. Il tribunale, con sentenza del 6.11.2003, accoglieva la domanda.
Affermava, a tal fine, che la mancata prestazione del consenso al trattamento da parte del paziente, non adeguatamente informato, costituiva autonoma fonte di responsabilità, restando irrilevanti la correttezza od adeguatezza tecnica delle cure prestate.
A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza in data 11.12.2006, accolse l’appello proposto dalla Regione Piemonte, Gestione Liquidatoria USL XX ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi S.G. .
Resiste con controricorso la Regione Piemonte, Gestione Liquidatoria USL XX.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2, 13 e 32 Costituzione nonché art. 29 codice deontologico in relazione all’art. 360 n. 3 C.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 C.c. e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5.
Con il terzo motivo si denuncia la omessa violazione e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e/o decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
I motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, che involgono, sotto diversi profili, la questione del consenso informato, sono trattati congiuntamente.
Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. In prima battuta, va sgombrato il campo dal profilo relativo alla sussistenza del nesso di causalità.
La Corte di merito, in proposito, ha accertato ed affermato -con ciò rigettando le censure sul punto mosse dall’appellante Regione Piemonte, Gestione Liquidatoria USL XX – che “Il ctu, sia a verbale, sia nelle sue note integrative in sede di chiarimenti, ha indicato, seppure in termini di verosimiglianza, da considerarsi elevata, la riconducibilità della patologia articolare femorale, e le conseguenze permanenti residuate dalla stessa, al trattamento cortisonico, indicando quest’ultimo tra le più frequenti cause, di natura iatrogena, di tale patologia, segnalate ed evidenziate in letteratura”.
Aggiungendo che “le restanti cause note della patologia in questione tra cui quelle di natura traumatica, o conseguenti a patologie vascolari e del metabolismo, ovvero l’alcolismo, sono da ritenere escluse del tutto nella fattispecie, come risulta incontestato”.
Precisando: “Restano le c.d. cause di natura “idiopatica”, che, in specie, sono da ritenere, del tutto verosimilmente, anch’esse escluse, proprio per l’antecedente e significativa presenza del trattamento cortisonico, che è invece indicato come causa nota, frequente, specifica e diretta della patologia in questione, dovendo pertanto confermarsi il giudizio del ctu, in termini di elevata verosimiglianza del nesso causale”.
Ed ha chiarito questo aspetto: “Vi è stata, infatti, una necrosi asettica iatrogena a seguito di trattamento con farmaci cortisonici come in specie si è verificato, essendo verosimilmente la complicanza in questione ascrivibile a detta e nota specifica origine anziché alle altre descritte dal ctu, in relazione alla precedente somministrazione dei cortisonici, ed essendo, invece, assenti o comunque non accertati, gli altri descritti fattori di rischio”.
Concludendo, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità: “Il quadro probatorio è pertanto del tutto univoco e non smentito né indebolito da elementi di segno contrario che ne denotino l’intrinseca contraddittorietà, ben integrando esso, pertanto, la prova piena e positiva del nesso di causalità, non ricorrendo, invece, la diversa ipotesi, invocata dall’appellante, dell’insufficienza del quadro probatorio”.
La Corte di merito ha, quindi, convalidato le conclusioni cui era pervenuta con l’ulteriore precisazione: “Né, d’altronde, può considerarsi significativo il lasso di tempo, non breve, di tre anni, intercorso tra il trattamento farmacologico e l’evento patologico, in assenza di alcun altro fattore che si sia autonomamente inserito nella suddetta concatenazione clinica, sì da determinare il sorgere di un’autonoma serie causale, collegabile eziologicamente, in tale stesso arco di tempo, alla malattia articolare. Né, d’altronde, in proposito, sussistono minori limiti temporali noti, contenuti, necessariamente, in un arco di tempo inferiore, per la possibilità di sviluppo della malattia femorale, dovendo pertanto considerarsi l’insorgere della stessa, anche a distanza di tempo, compatibile col quadro eziologico su delineato”.
Questo punto della decisione non è stato colpito da alcuna censura; con la sua conseguente, attuale incontrovertibilità in questa sede.
Passiamo, ora, ad esaminare la questione centrale nell’impianto della sentenza impugnata: quella del consenso informato, delle sue caratteristiche e dei corollari in tema di eventuale inadempimento e risarcimento del danno.
Le proposizioni argomentative che hanno condotto la Corte di merito a negare la responsabilità della struttura sanitaria, escludendo la doverosità di un risarcimento dei danni, sono le seguenti:
a) In tema di consenso informato non può escludersi la rilevanza della qualità rivestita dal paziente – medico anch’egli, in qualità di radiologo, presso la stessa struttura sanitaria in cui era stato ricoverato “ai fini di ritenere raggiunta la prova della sua consapevole adesione al trattamento, pur in assenza….di una dichiarazione scritta, ai fini di ritenere acquisito”. E ciò “potendo ben presumersi che, al di là delle comunicazioni protocollari, il caso clinico, in specie, anche per il suo intrinseco interesse, sia stato ampiamente discusso e approfondito, con lo stesso paziente, allorché uscito dalla fase critica, dai medici della struttura nonché colleghi di lavoro del S. “.
b) Il codice di deontologia medica (art. 29) prevede che il consenso – e la relativa corretta informazione – debba essere riferito “al livello di cultura ed alle capacità di discernimento del soggetto”. “E se tale principio vale di certo a tutelare il paziente digiuno di ogni nozione medica, verso il quale l’attenzione, anche sul piano della scelta di un linguaggio e di singoli termini lessicali, chiari e comprensibili, deve essere massima, tale esigenza non può ugualmente ravvisarsi qualora il paziente sia invece particolarmente edotto della materia, ovvero quando, come in specie, ricorrano specifiche circostanze di fatto che rafforzino la presunzione di una sua adesione consapevole al trattamento clinico, indipendentemente da comunicazioni formali”.
Ed in questo senso “….pertanto, il grado di acquisita conoscenza e consapevolezza deve essere, in concreto, e non solo in termini di linguaggio usato per comunicare, effettivamente parametrato al grado delle conoscenze del paziente in esame, alle quali, in specie, si aggiunge, quale fonte indiretta di piena consapevolezza del trattamento clinico-farmacologico, e delle sue implicazioni, l’appartenenza del dr. S. al qualificato contesto professionale della struttura ospedaliera da cui il medesimo dipendeva, quale radiologo, avendo in fatto egli un rapporto diretto con i propri medici curanti, dei quali era anche collega di lavoro”.
c) L’attore non ha provato di “non avere affatto ricevuto, o comunque acquisito una sufficiente conoscenza dei rischi cui era esposto” ed una tale prova incombeva all’attore. In tal modo non era stata adeguatamente superata “la presunzione logicamente derivante da tale contesto, nei termini di una maggiore ampiezza conoscitiva, dovuta allo scambio di informazioni tra colleghi sul peculiare ed interessante caso clinico di un’infezione meningea contratta, a seguito della somministrazione di un vaccino antinfluenzale, da un medico e collega di lavoro”.
d) Ricorrevano, nella specie, una serie di elementi che “sia in via diretta che presuntiva, tale conoscenza e consapevolezza (relative alla particolarità del caso clinico ed alla specificità della terapia praticata al paziente) dovevano, invece, far ritenere in concreto, acquisita proprio in relazione a tale qualificato stato soggettivo del paziente e al contesto umano e professionale in cui il medesimo si trovava inserito, allorché contrasse la malattia e fu curato presso la stessa struttura da cui dipendeva”.
Ulteriore elemento, dal quale era consentito inferire un ulteriore elemento di consapevolezza del paziente era rappresentato dalla circostanza che la stessa moglie del S. “era un medico dipendente dello stesso ospedale di XXXXXX, avendo avuto, pertanto, modo di interloquire, anche al di fuori del linguaggio ufficiale e protocollare, con i colleghi di lavoro, circa le terapie più idonee da somministrare al singolare paziente, nonché, proprio coniuge”.
e) Anche la complicanza iatrogena, “proprio perché non anomala né imprevedibile (come definita dal ctu), e in concreto verificatasi, ben poteva, più che presumibilmente rientrare tra le specifiche conoscenze del dr. S. , che, peraltro, quale radiologo, aveva sicuramente, per specifica competenza, piena contezza delle più diverse patologie articolari, fra cui quella femorale che lo aveva colpito, nonché, necessariamente delle loro cause scatenanti, specie se, come emerso dalla ctu, clinicamente frequenti”.
Tali elementi sono stati giudicati dalla Corte di merito “tutti univoci, sotto un elevato profilo presuntivo, e non contraddetti da fattori di segno opposto, concreti, o anch’ essi presunti, e idonei di per sé a far ritenere in concreto acquisita da parte del dr. S. , detta conoscenza e consapevolezza del rischio clinico legato al trattamento”. A questi, la Corte di merito ha ritenuto di affiancarne ulteriori definiti “di natura oggettiva ed anch’essi univocamente in grado di attestare, unitamente ai primi, tale raggiunta consapevolezza ed accettazione del trattamenti praticato”.
Tali sono definite le “chiari ed esaustive annotazioni sulla cartella clinica, all’atto delle dimissioni”, cartella clinica che “oltre al dosaggio scalare del farmaco, nelle settimane successive, elemento indicativo di per sé, e in special modo ad un medico, della portata precauzionale e prudenziale della prescrizione, volta ad evitare i rischi di complicanze, specie in relazione alla natura cortisonica del farmaco in esame, conteneva anche la raccomandazione al paziente di sottoporsi a visita di controllo, per determinare le scelte terapeutiche e la posologia successiva, anche in tal caso contribuendo, tale precisa indicazione terapeutica, a rafforzare la consapevolezza circa l’esigenza di monitorare le fasi successive del processo di convalescenza e di guarigione, non scontata, e necessitante di controlli”.
Un tale percorso argomentativo non può essere seguito, né le implicazioni che la Corte di merito ne ha fatto scaturire, sono condivisibili.
Queste le ragioni.
Sono principi ormai acquisiti nella giurisprudenza della Corte di cassazione i seguenti.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.
Senza il consenso informato l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente.
Il consenso informato ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell’eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748).
Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub n. 4 del Considerato in diritto) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi – in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass. 28.7.2011 n. 16543).
In ordine alle modalità e caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale: deve, cioè provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23.5.2001 n. 7027); inoltre reale ed effettivo; ciò che vuoi significare che non è consentito il consenso presunto; ed, ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, anche attuale (v. per le relative implicazioni Cass. 16.10.2007 n. 21748). Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere “informato”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Se questi sono i principi che si applicano in materia di consenso informato, è di tutta evidenza che le indicazioni fornite sul punto dalla Corte di merito, in quanto sostanzialmente fondate soltanto su argomenti di natura presuntiva, non possano essere seguite.
La sentenza impugnata confonde il consenso presunto con la prova di un consenso reale ed effettivo.
Si ha consenso presunto – come tale inammissibile – nel caso in cui si ritiene che il soggetto in quel dato contesto situazionale avrebbe sicuramente dato il consenso se gli fosse stato richiesto.
Si ha, invece, prova mediante indizi del consenso prestato quando realmente in un certo momento temporalmente definito c’è stata effettiva richiesta ed effettiva prestazione del consenso. Solo che la prova di tale consenso viene data, non attraverso un documento scritto, ma attraverso testimonianze ed indizi (si faccia il caso che il documento con cui il paziente prestava il suo consenso è andato distrutto).
A scanso di equivoci va aggiunto che – dati i valori in gioco – non esiste un consenso tacito per facta concludentia.
Il consenso deve tradursi in una manifestazione di volontà effettiva e reale.
È la prova del consenso che – in caso di impossibilità di prova documentale – può essere fornita con altri mezzi.
Come dire che il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, ma richiede comunque una manifestazione reale, cioè concretamente avvenuta hic et nunc.
Chiariti i termini giuridici della questione, si nota subito come molti degli argomenti della sentenza impugnata siano irrilevanti.
In sostanza, l’argomento principale della sentenza può essere stilizzato come segue: il paziente era un medico, quindi aveva le cognizioni scientifiche necessarie per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto; faceva parte della stessa struttura ospedaliera e quindi aveva un contatto frequente con i medici curanti; ora, se docilmente si è sottoposto alla cura, questo vuoi dire che era d’accordo; cioè si è sottoposto cura, questo vuoi dire che era d’accordo; cioè si è sottoposto volontariamente alla terapia nella consapevolezza (derivante dalle sue cognizioni mediche) dei rischi della stessa.
L’argomento è all’evidenza irrilevante perché -anche se fondato- ci porterebbe direttamente al consenso presunto.
Infatti, l’argomento non dimostra che effettivamente vi fu una richiesta di consenso e una prestazione di consenso.
L’argomento dimostra soltanto che i medici hanno, in buona fede, presunto che il paziente fosse d’accordo.
Ma la legge richiede ben altri e più rigorosi requisiti.
In questa prospettiva si appalesano irrilevanti ulteriori argomenti.
In particolare, è privo di consistenza il riferimento all’art. 29 del codice di deontologia medica (art. 29) che prevede che il consenso – e la relativa corretta informazione – debba essere riferito “al livello di cultura ed alle capacità di discernimento del soggetto”, poiché al medico, in questo caso, non si contesta la violazione del codice deontologico, quanto l’avere “operato” in assenza di un consenso informato.
Può, quindi, sostenersi che, pur non essendovi violazione del codice deontologico, sussiste, invece responsabilità medica; e ciò proprio perché i due ordinamenti agiscono su piani diversi: l’uno disciplinare, l’altro civilistico.
A questo punto, ci si deve domandare se questo assetto di regole e di condotte muti in considerazione della qualità del paziente che deve fornire il consenso; ciò che vorrebbe dire che i principi si atteggiano diversamente, pervenendo perfino ad escludere rilevanza causale alla mancanza di consenso informato in caso di paziente “medico”. La risposta è negativa.
La finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all’autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica (v. anche Cass. 9.2.2010, n. 2847). È, quindi, evidente l’irrilevanza della qualità del paziente al fine di escluderne la doverosità.
La qualità del paziente potrà, invece, incidere sulle modalità di informazione – informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente – con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia.
E ciò in particolare nel caso in esame, se – come risulta non contestato – la complicanza iatrogena dovuta al trattamento cortisonico e causatrice della necrosi delle due teste del femore – era da considerarsi frequente in caso di trattamenti del genere.
In tal modo, il paziente sarebbe stato in grado di scegliere se proseguire o meno la terapia indicata, od, eventualmente, preferire un farmaco diverso, di minore durata e con un dosaggio più contenuto.
Erra, pertanto, la Corte di merito quando, sotto questo profilo, afferma non potersi escludere “la rilevanza della qualità rivestita dal paziente – medico anch’egli, in qualità di radiologo, presso la stessa struttura sanitaria in cui era stato ricoverato” ai fini di ritenere raggiunta la prova della sua consapevole adesione al trattamento, pur in assenza…. di una dichiarazione scritta”; e su tale base presume “che, al di là delle comunicazioni protocollari, il caso clinico, in specie, anche per il suo intrinseco interesse, sia stato ampiamente discusso e approfondito, con lo stesso paziente, allorché uscito dalla fase critica, dai medici della struttura nonché colleghi di lavoro del S. “.
Ma il ragionamento presuntivo – di cui si è già detto – parte da un fatto noto per ritenere raggiunta la prova di quello ignoto.
Ciò che difetta, nella specie, è la notorietà di quello considerato noto, che si basa, anch’esso, su di una presunzione; come visto, due presunzioni ininfluenti al fine di ritenere prestato il richiesto consenso alla terapia adottata.
Ancora, non sono condivisibili le argomentazioni – di cui la Corte di merito fa largo uso nelle sue considerazioni – basate sui principi della “consapevolezza e la conoscenza”, che sono soltanto conseguenza di un consenso, ma non l’essenza stessa del consenso.
Sono, quindi, le modalità – ossia il quomodo delle informazioni che il medico deve fornire – che possono variare in considerazione del grado di conoscenze specifiche del paziente; il consenso, però, non può essere presunto, ma deve essere effettivo.
A questo punto, l’ulteriore passo da effettuare è stabilire a chi incomba l’onore di provare l’avvenuto od il mancato adempimento dell’obbligo di informazione.
Sotto questo profilo, è ormai principio incontestato che l’intervento stesso del medico, anche solo in funzione diagnostica, determini l’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale.
Con la conseguenza che, una volta effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento – al fine di ottenere il necessario consenso all’esecuzione della prestazione terapeutica – costituisce un’obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente.
Dunque, dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente (v. anche (Cass. 9.2.2010 n. 16543; Cass. 9.2.2010 n. 2847).
Erra, pertanto, la Corte di merito quando afferma che l’attore non ha provato di “non avere affatto ricevuto, o comunque acquisito una sufficiente conoscenza dei rischi cui era esposto ed una tale prova incombeva all’attore”; con ciò onerando di una tale prova – oltretutto negativa e contraria al principio di vicinanza alla prova di cui all’art. 24 Cost. – il paziente.
Questi gli snodi argomentativi che la Corte di merito ha in modo erroneo trattato e che l’hanno condotta ad una conclusione non in linea con i principi enunciati.
Alla luce degli stessi, il giudice del rinvio dovrà esaminare la vicenda in questione.
Alcuni corollari.
Corollario di quanto fin qui detto è che il rispetto dell’autodeterminazione del paziente – che è ciò che si vuole tutelare, con il conseguente risarcimento del danno per mancato consenso – deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si ponevano di fronte al paziente, nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato.
A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso (v. anche Cass. 13.7.2010 n. 16394; Cass. 9.2.2010 n. 2847).
Ciò vuoi dire che l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno, nelle obbligazioni così dette di comportamento, non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Il che comporta: a) da un lato, la necessità, per la parte istante, di allegare un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno; b) che la sussistenza del nesso eziologico va indagata, non solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento o terapia adottata e pregiudizio della salute, ma – ove sia allegata la violazione del consenso informato – anche in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico, per non aver informato il paziente, ed esecuzione dell’intervento o adozione di una determinata terapia.
Sempre nell’ottica che il diritto all’autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute (Cass. 13.7.2010 n. 16394; Cass. 9.2.2010 n. 2847; Cass.11.5.2009 n. 10741; Cass. 3.9.2007 n. 18513); con la conseguenza di un risarcimento fondato su diverso titolo in ipotesi di violazione del primo, ma non del secondo.
La risarcibilità del danno da lesione della salute, che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’intervento medico necessario o della terapia adottata, entrambi correttamente eseguiti, ma senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, dunque, in assenza di un consenso consapevolmente prestato, richiede l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.