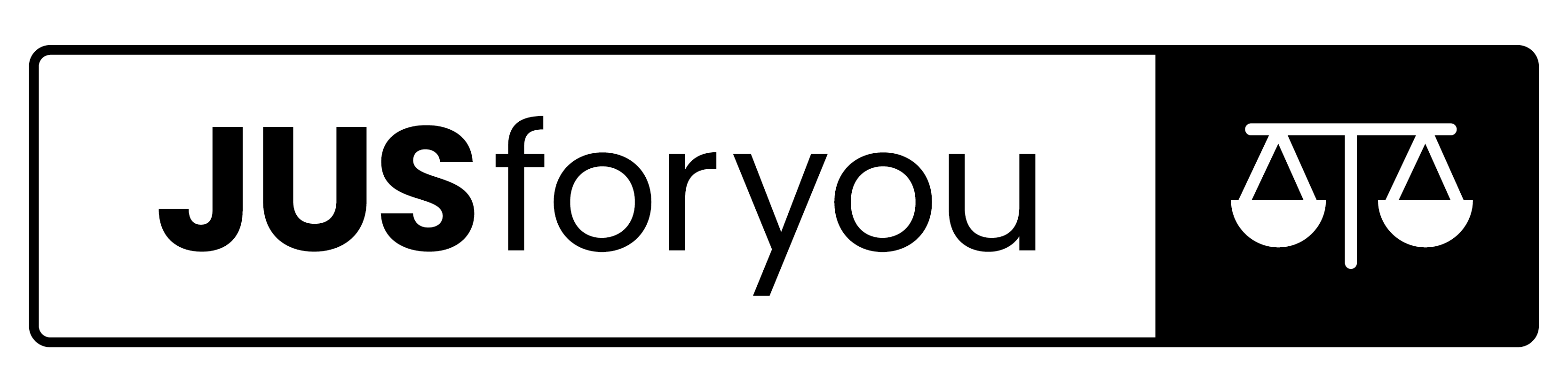1. Le obbligazioni possono sorgere da rapporti di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benché questo contatto non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità a contenuto contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo.
La situazione descritta si riscontra nei confronti dell’operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente, quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost..
Rispetto all’operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere – e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità -, ma proprio quel facere, nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento. La responsabilità, sia del medico, sia dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha, dunque, contenuto contrattuale ed è quella tipica del professionista.
2. Quanto all’onere della prova, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
3. Il primario ospedaliero, che, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi. E ciò, al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002). Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 e. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).
I quesiti posti rispettano i requisiti richiesti dalla norma dell’art. 366 bis c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente denuncia a) nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa (artt. 275 secondo comma, 352 e 101 c.p.c, artt. 3, 111 secondo comma e 24 secondo comma della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.); b) violazione in ogni caso degli artt. 275 terzo e quarto comma e 352 c.p.c. e dell’art. 24 secondo comma, nonché dell’art. 111 sesto comma della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che è principio condiviso nella giurisprudenza della Corte di legittimità che l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c. non comporti necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
E ciò perché l’art. 360 n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Inoltre, avendo la discussione della causa, nel giudizio d’appello, una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e, non essendo sostitutiva delle difese scritte di cui all’art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (Cass. 5.12.2003 n. 18618).
L’applicabilità di questi principi, però, necessita di un elemento pregiudiziale, vale a dire che la richiesta di discussione orale sia rituale ai sensi dell’art. 352, secondo comma c.p.c..
Prevede, infatti, tale norma che ‘ Se l’appello è proposto alla corte dr appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica’.
Ebbene, nel caso in esame di una tale riproposizione, sulla quale il presidente provvede ai sensi del terzo comma dello stesso art. 352 c.p.c., non vi è traccia; né il ricorrente dimostra – e riproduce in ricorso – il tenore ed i tempi di tale richiesta, debitamente riproposta; con la conseguente declaratoria di infondatezza del motivo.
Con il secondo motivo si denuncia nullità della C.T.U. espletata in primo grado con conseguente nullità derivata della sentenza della Corte d’Appello che l’ha interamente recepita, ancora una volta per lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (‘error in procedendo’ con violazione degli Artt. 61, 101, 122 e 123 c.p.c., 3 e 24 secondo comma della Costituzione, in relazione all’Art. 360 n. 4 c.p.c.).
Il motivo non è fondato sotto due concorrenti profili.
In ordine al primo, sarebbe addirittura inammissibile perché nuovo.
Non risulta, infatti, che la censura relativa alla supposta nullità della c.t.u., per le ragioni che si vanno più oltre ad indicare, sia stato proposta nel giudizio di appello; né la ricorrente, al fine di evitare la declaratoria di novità, indica in quali atti processuali sarebbe stata già proposta riproducendone il contenuto nel ricorso per cassazione.
Né il rilievo può essere superato da una tale indicazione contenuta nella memoria – nella specie depositata ex art. 378 c.p.c. – la cui funzione è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso, ma non di integrarli con gli elementi mancanti (v. da ultimo Cass. 15.4.2011 n. 8749).
In ogni caso, anche a tralasciare un tale profilo, l’infondatezza del motivo scaturisce dall’insussistenza dei rilievi avanzati.
La nullità, infatti, è predicata per avere il c.t.u. ‘posto a fondamento della propria relazione pubblicazioni in lingua inglese senza la traduzione in lingua italiana quanto meno dei passaggi richiamati e fatti propri’ (così nel quesito posto al termine della illustrazione del motivo).
Ma, il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana – previsto dall’art. 122 c.p.c. – si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti. Quindi, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l’obbligo, di nominare un traduttore, per cui, il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (da ultimo Cass. 16.6.2011 n. 13249; Cass. ord. 23.2.2011 n. 4416).
La consulenza tecnica d’ufficio, regolarmente redatta in lingua italiana – che nella specie la ricorrente ritiene fondata su pubblicazioni in lingua inglese – è, pertanto, esente dai rilievi avanzati.
Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione degli artt. 2236, 1176, 1218, 1223, 1226, 2043 2056 e 2059 c.c. nonché degli artt. 2 e 32 della Costituzione (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte di merito, nel contestare le valutazioni della consulenza di parte – considerata ‘come illustrazione delle ragioni dell’appellante’ – mostra di ritenere non condivisibile il rilievo per il quale ‘anziché indirizzare la paziente al reparto oncologico dello stesso ospedale essi avrebbero dovuto rivalutare il caso e discuterlo collegialmente assieme agli oncologi’.
E ciò perché il direttore della clinica chirurgica consigliava al medico di base di sottoporre la M. – appena in condizioni di essere dimessa – a visita oncologica specialistica; indicazione questa ritenuta ‘pienamente congrua e condivisibile anche se il primo referto anatomo – patologico sulla biopsia avesse avuto un significato equivocabile’, non sembrando ‘condivisibile l’osservazione che già a quel momento fosse evidente la diagnosi di emangioendotelioma epitelioideo anziché l’adenocarcinoma’. Aggiunge la Corte che ‘a quella più corretta diagnosi si giunse un anno e mezzo dopo, ma certamente vi contribuirono le osservazioni sui risultati della chemioterapia praticata in quel di …’ affermando non essere decisiva ‘l’assenza di valori pericolosi dei due marcatori tumorali CA 19.9 e CEA.’. E conclude, in ordine ai rilievi avanzati dal consulente di parte ed esaminati come ragioni di impugnazione: ‘Non sono le chiacchiere estemporanee di pur dotta persona ad influenzare una decisione giudiziaria, sia pur per disporre il rinnovo della consulenza’.
Ebbene, sotto questo primo profilo, per un verso, è evidente la carenza motivazionale in cui è incorsa la Corte di merito in ordine ai rilievi critici mossi dal consulente di parte – e riportati in ricorso – alla consulenza tecnica d’ufficio ai fini di un rinnovo della consulenza in appello esaminati ‘quali ragioni di impugnazione’, limitandosi la Corte di merito – nell’aderire alla consulenza di ufficio – ad affermare che ‘sia per la rarità di quelle neoplasie, sia per la possibilità di confondimento diagnostico, non era frutto di imperizia, imprudenza o negligenza la diagnosi fatta dall’anatomo patologo prof. P. ‘. Trova, nella specie, applicazione il principio secondo il quale è affetta da vizio di motivazione la sentenza che, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia dovutamente prese in considerazione e si sia, invece, limitata a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (Cass. 2.12.2011 n. 25862; Cass. 24.4.2008 n. 10688; Cass. 1.3.2007 n. 4797).
Dal rilievo che la consulenza tecnica di parte non è mai un mezzo di prova, ma solo un atto difensivo e che, dunque, il Giudice non è tenuto a discuterne ex professo le conclusioni quando ritenga di aderire a quelle del consulente di ufficio (v. anche S.U. 9.3.1965, n. 375), non è, infatti, consentito trarre il corollario che egli possa anche totalmente prescindere dai rilievi precisi e circostanziati che il consulente di parte abbia mosso agli argomenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. 2.2.2011 n. 25862; Cass. 24.4.2008 n. 19688; Cass. 16.6.2001 n. 8165).
E ciò perché il potere del Giudice di merito, di apprezzare il fatto, non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, quindi, dalla spiegazione delle ragioni – fra le quali evidentemente non può considerarsi prevalente la maggiore fiducia che egli eventualmente tenda ad attribuire al consulente d’ufficio quale proprio ausiliare – per le quali sia pervenuto ad una conclusione anziché ad un’altra, incorrendo, altrimenti, nel vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (Cass.13.1.2005, n. 582).
In tali casi, la possibilità per il Giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d’ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (fra le varie Cass. 2.5.2006 n. 10133).
Ciò che, nella specie, non è avvenuto. Non solo.
Ma la Corte omette anche di chiarire e motivare le ragioni per le quali non sarebbe ‘condivisibile l’osservazione che già a quel momento fosse evidente la diagnosi di ‘emangioendotelioma epitelioideo’ anziché l’adenocarcinoma’.
Né l’affermazione, sempre immotivata, del perché soltanto dopo un anno e mezzo si poté giungere ‘a quella più corretta diagnosi’, alla quale contribuirono ‘certamente’ ‘le osservazioni sui risultati della chemioterapia praticata in quel di …’ è sostenuta dalla indicazione delle ragioni di un tale convincimento.
Il carattere assertorio della sentenza impugnata non può essere condiviso in assenza di una congrua e convincente motivazione. Ed a tale conclusione deve pervenirsi anche con riferimento al rilievo per il quale la Corte di merito ha ritenuto priva di decisività la circostanza dell’assenza ‘di valori pericolosi dei due marcatori tumorali CA 19.9 e CEA’; rilievo, questo, meramente allegato; come tale – in difetto di motivazione sulle ragioni per le quali la circostanza è stata considerata non decisiva – privo di consistenza.
Ed allora, già sotto questi primi profili, per le ragioni indicate, la sentenza impugnata non può considerarsi esente dalle critiche motivazionali che le sono state mosse dall’odierna ricorrente.
Passando, quindi, all’esame delle potenziali colpe ascrivibili agli odierni intimati e del percorso logico argomentativo che ha condotto il giudice del merito ad escludere ogni profilo di colpa -, la Corte di merito ritiene – sulla scorta delle conclusioni della c.t.u. – che ‘sia per la rarità di quelle neoplasie, sia per la possibilità di confondimento diagnostico, non era frutto di imperizia, imprudenza o negligenza la diagnosi fatta dall’anatomo patologo prof. P. ‘.
Ed, a tal fine, afferma: ‘Trattandosi di errore scusabile in situazione che ai sensi dell’art. 2236 c.c. per la speciale difficoltà della diagnosi, avrebbe limitato la responsabilità al caso della colpa grave, nulla può essere addebitato al prof. P. ; tantomeno può muoversi rimprovero al chirurgo prof. Mi. che si comportò secondo i migliori canoni dettati dalla prudenza o dal rispetto verso la paziente subito richiedendo l’analisi della biopsia nel corso dell’intervento e comportandosi come quel referto imponeva. Del tutto estraneo alla vicenda è stato il prof. Ma. , cui non si poteva attribuire il dovere di ripetere quell’esame, senza un motivo valido per farlo, e che sarebbe stato seriamente in colpa se non avesse riferito e consigliato al curante di far visitare la paziente a uno specialista oncologo’. Concludendo: ‘Poco importano i rilievi sulla conseguente terapia, che comunque si giustificava come scelta di maggior prudenza. La scusabilità dell’errore diagnostico impone il rigetto dell’appello’.
Orbene, anche tali conclusioni non possono essere condivise. La limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (fra le varie Cass.1.3.2007 n. 4797; Cass. 19.4.2006 n. 9085; Cass. 29.7.2004 n. 14488; Cass. 10.5.2000 n. 5945; Cass. 18.11.1997 n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166).
Il giudice del merito, nel caso in esame, si è attestato sulla scusabilità dell’errore diagnostico per la speciale difficoltà della diagnosi – rilievo questo relativo alla sola perizia, peraltro neppure debitamente motivato in relazione alle particolarità del caso concreto – per escludere la responsabilità a vario titolo dei soggetti coinvolti, ma nulla ha detto con riferimento alle altre due ipotesi: negligenza o imprudenza che, se ricorrenti, sono fonte di responsabilità contrattuale anche nei casi di speciale difficoltà.
Anche in questo caso, – unitamente alla non corretta applicazione dei principii in tema di responsabilità professionale medica ex art. 2236 c.c. che depongono per la sussistenza dell’ipotesi di violazione di legge – si tratta anche di evidente vizio motivazionale, che ha condotto a scelte decisionali non condivisibili perché fondate soltanto su di un aspetto di tale responsabilità.
Ed a una tale conclusione si perviene, ancora una volta, anche con riferimento alla indicazione desunta dalla c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, laddove la Corte di merito si è uniformata al giudizio tecnico – che aveva concluso che ‘ sia per la rarità di quelle neoplasie, sia per la possibilità di confondimento diagnostico, non era frutto di imperizia, imprudenza o negligenza la diagnosi fatta dall’anatomo patologo prof. P. ‘ -, senza procedere ad una autonoma valutazione delle condotte in relazione ai profili della imprudenza e negligenza.
Da ultimo, non meno viziata appare l’affermazione alla quale perviene la sentenza – dopo avere concluso per la scusabilità dell’errore diagnostico – ‘Poco importano i rilievi sulla conseguente terapia, che comunque si giustificava come scelta di maggior prudenza’.
Un tale assunto, ancora una volta, avrebbe potuto essere condivisibile soltanto se il giudice del merito avesse argomentato di quali rilievi si fosse trattato, la loro irrilevanza e le ragioni sulle quali fondava una tale conclusione; invece apodittica.
Diversamente, anche i successivi aspetti fattuali della vicenda avrebbero potuto gettare una luce chiarificatrice sulle ipotizzate responsabilità.
Questi gli snodi argomentativi che la Corte di merito ha in modo erroneo trattato e che l’hanno condotta ad una conclusione non in linea con i principi enunciati.
Il caso in esame – per le sue peculiarità – richiede un più approfondito e puntuale esame da parte del giudice del merito, al fine di cogliere le diverse problematiche che investono le condotte dei sanitari, i profili di eventuale responsabilità, il nesso di causalità e la ricorrenza del potenziale danno risarcibile.
Alla luce dei principii esposti dovrà essere condotto l’esame da parte del giudice del rinvio.
Merita precisare alcuni corollari applicabili alla fattispecie in esame.
Sono principii ormai pacifici nella giurisprudenza della Corte di legittimità in tema di responsabilità medica i seguenti.
La responsabilità dell’ente ospedaliere è di natura contrattuale; e ciò perché l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. 3.2.2012 n. 1620; Cass. 16.1.2009 n. 975; S.U. 11.1.2008 n. 577; Cass. 14.6.2007 n. 13953; Cass. 13.4.2007 n. 8826; Cass. 19.4.2006 n. 9085).
A sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente dall’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale – cioè su altro fatto idoneo a produrre l’obbligazione ex art. 1173 c.c. -, ha contenuto contrattuale (v. per es. Cass.7.10.2010 n. 20808; Cass. 19.4.2006 n. 9085; Cass. 28.5.2004 n. 10297).
Secondo questa condivisibile giurisprudenza, le obbligazioni possono sorgere da rapporti di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto.
Benché questo contatto non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità a contenuto contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo.
La situazione descritta si riscontra nei confronti dell’operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente, quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost..
Rispetto all’operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere – e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità -, ma proprio quel facere, nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento.
La responsabilità, sia del medico, sia dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha, dunque, contenuto contrattuale ed è quella tipica del professionista.
Ne deriva che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa, e la prescrizione ordinaria.
Quanto all’onere della prova, in particolare, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. 9.10.2012 n. 17143; Cass. 21.7.2011 n. 15993; Cass. 8.10.2008 n. 24791).
Inoltre, in relazione alla responsabilità del primario, vale ricordare Cass. 29.11.2010 n. 24144 che ha affermato che il primario ospedaliero, che, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi.
E ciò, al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.
Anche di questi principi dovrà tenere conto il giudice del rinvio nell’esaminare il caso concreto.
Conclusivamente, sono rigettati il primo e secondo motivo; è accolto il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo. Accoglie il terzo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.