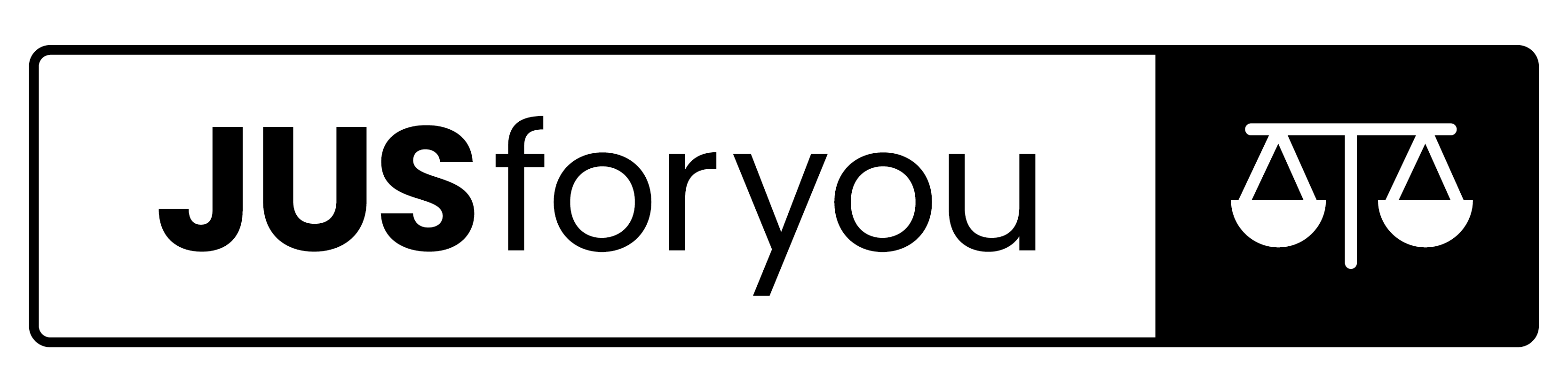Cass. civ., Sez. III, 23 aprile 2020, n. 8137 – Pres. Amendola, Rel. Cricenti
La regola propria dell’illecito civile, secondo cui il risarcimento va commisurato al danno subito dal danneggiato, e non deve essere superiore a questo, può subire eccezioni quando l’illecito sia connotato dai presupposti propri dell’arricchimento senza causa, che sono, per l’appunto, quelli di una condotta di interferenza nei beni altrui, e di sfruttamento illecito delle loro potenzialità. Pertanto, nei casi in cui il fatto illecito procura un arricchimento superiore al danno, il danneggiato può agire per l’intero l’arricchimento, solo se esso deriva da una particolare condotta: quella di sfruttamento indebito di beni o risorse altrui. In questi casi, infatti, è applicabile direttamente o analogicamente l’articolo, 2032 c.c., quando l’operato abusivo sia ratificato dal danneggiato, che dunque fa proprio l’utile netto.
Il ricorso nasce da una controversia risalente nel tempo, e risolta in tre diverse cause, tutte tra le stesse parti.
In sintesi, per il tramite del quotidiano “(omissis) “, la società editrice Poligrafici Editoriale spa ha pubblicato alcuni articoli in cui alludeva al coinvolgimento dell’avvocato F.F. in fatti di terrorismo degli anni (omissis), compresa la (omissis) .
Per tali allusioni la società editrice è stata condannata, in diversi giudizi, al risarcimento dei danni da diffamazione, prima a favore del suddetto F. , e poi, dopo la sua morte, degli eredi (moglie e due figli).
Nel terzo dei giudizi intentati dal diffamato la società editrice Poligrafici è stata altresì condannata alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna su diversi quotidiani nazionali.
Non avendo ottemperato a quest’ordine, gli eredi F. hanno agito in giudizio per il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Firenze ha ritenuto di dover quantificare il danno nella misura corrispondente all’arricchimento del danneggiante, ossia al costo da quest’ultimo risparmiato omettendo la pubblicazione, ed ha dunque stimato il risarcimento in 136 mila Euro.
La Corte di Appello invece ha ritenuto che l’ammontare del danno dovesse ridursi in ragione della inerzia dei danneggiati che, pur potendo provvedere a loro spese alla pubblicazione (art. 120 c.p.c.), non lo hanno fatto, cosi contribuendo al danno subito (art. 1227 c.c.).
La Corte di cassazione, con sentenza 2087 del 2015, ha smentito questa tesi, annullando con rinvio ed affermando il principio di diritto secondo cui l’inerzia del danneggiato che non provvede da sé alla pubblicazione della sentenza, non costituisce concorso colposo valutabile ai fini del risarcimento.
Il giudizio di rinvio, dunque, aveva ad oggetto di decisione la stima del danno subito dai ricorrenti, eredi del F. , per l’omessa pubblicazione della sentenza di condanna, danno che andava stimato senza tener conto della incidenza del concorso dei danneggiati.
La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio, ha ritenuto che il danno non potesse stimarsi come aveva fatto il Tribunale di Firenze a suo tempo, ossia tenendo conto dell’arricchimento del danneggiato, vale a dire del costo risparmiato da costui per l’omessa pubblicazione, ma dovesse valutarsi in base all’art. 2043 c.c., ed andasse, proprio in tale ottica, stimato equitativamente non essendovi parametri oggettivi cui ancorarlo.
Ha dunque riconosciuto una somma inferiore (100 mila Euro) rispetto a quella liquidata a suo tempo dal Tribunale (136 mila).
Avverso tale sentenza ricorrono gli eredi F. con due motivi, l’uno subordinato all’altro, di cui chiede il rigetto la società Poligrafici Editoriale spa che si è costituita con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.
Ragioni della decisione
1.- La ratio della decisione impugnata.
La sentenza di appello, in sede di rinvio, ha qualificato la condotta del diffamante, che omette di ottemperare all’ordine di pubblicazione della sentenza, come un caso di fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Ciò ha fatto anche sulla scorta della ratio del rimedio della pubblicazione della sentenza di condanna, sul presupposto che funzione di quella misura è di integrare il risarcimento, ossia di fornire una riparazione del danno subito, complementare a quella che può venire dal risarcimento per equivalente; cosi che anche l’ordine di pubblicare la sentenza ha uno scopo risarcitorio, e la sua violazione provoca un danno risarcibile nei termini di cui all’art. 2043 c.c., dunque nei termini del pregiudizio subito.
Con la conseguenza che, trattandosi di un pregiudizio non stimabile con criteri oggettivi, ne è imposta una valutazione equitativa.
2.- Le ricorrenti contestano questa tesi con due motivi subordinati l’uno all’altro.
Con il primo motivo lamentano violazione degli artt. 2041 e 1226 c.c.
Sostengono che è errato ritenere che il danno da risarcire coincida con il pregiudizio subito dai danneggiati, senza tener conto dell’arricchimento che invece ha avuto il danneggiante mediante il fatto illecito; che dunque si dovrebbe applicare alla fattispecie l’art. 2041 c.c. e non già l’art. 2043 c.c., anche in ragione della funzione del rimedio della pubblicazione della sentenza che non è meramente risarcitorio e non è complementare al risarcimento per equivalente.
Con il secondo motivo, invece le ricorrenti propongono una censura subordinata al mancato accoglimento della prima, denunciando violazione degli art. 1226 e 2043 c.c., nel senso che ove si dovesse ritenere che il danno coincide con la mera perdita senza alcun rilievo per l’arricchimento, allora la stima effettuata dalla corte è motivata in maniera apodittica e non tiene conto della gravità delle ripercussioni che la diffamazione ha avuto nell’ambito familiare, oltre che erronea quanto al calcolo degli accessori.
3.- Il primo motivo è infondato.
Va svolta una premessa.
La società editrice ritiene che il motivo sia inammissibile in quanto la domanda di valutazione del danno ai sensi dell’art. 2041 c.c. sarebbe stata abbandonata dalle ricorrenti, che non l’avrebbero riproposta nel giudizio di rinvio.
L’eccezione è infondata.
Intanto, nelle conclusioni del giudizio di rinvio le ricorrenti hanno chiesto la liquidazione del risarcimento nella misura corrispondente al costo delle pubblicazioni omesse, come accertato dalla CTU di primo grado, e dunque la liquidazione nei termini dell’arricchimento avuto dalla editrice.
In secondo luogo, poco importa che non abbiano espressamente indicato l’art. 2041 c.c. quale norma di riferimento per tale tipo di liquidazione, posto che l’indicazione della norma di riferimento è irrilevante e non vincola il giudice nella qualificazione del fatto.
Del resto, la corte di appello ha qualificato la domanda di risarcimento come avente titolo in un fatto illecito (art. 2043 c.c.) e non già come domanda di arricchimento ingiustificato, e si tratta di una qualificazione corretta.
Arricchimento ingiustificato ed illecito civile hanno molti punti in contatto, e quando i codificatori hanno disciplinato l’azione di arricchimento pensavano proprio ai presupposti dell’illecito, tanto che si tratta di due modi diversi di affrontare lo stesso problema: dal lato della riparazione del danno, la responsabilità civile; dal lato dell’arricchimento l’azione ex art. 2041 c.c.
Elementi comuni sono del resto l’ingiustizia del danno, la correlazione tra arricchimento e pregiudizio altrui, gli stessi requisiti dell’ingiustizia.
Invece, le differenze ricadono sull’elemento soggettivo, nel senso che un arricchimento realizzato a danno altrui con dolo e colpa configura piuttosto un illecito che un caso riferibile alla fattispecie di cui all’art. 2041 c.c., norma quest’ultima riservata dunque agli arricchimenti realizzati a danno altrui, ma privi dell’elemento soggettivo proprio dell’illecito civile, e da qui la residualità della corrispondente azione.
Questo si dice a conferma della corretta qualificazione effettuata dalla corte di appello, che ha ravvisato nella condotta della società editrice l’elemento soggettivo proprio di un illecito civile, ossia la volontà di non voler adempiere all’ordine di pubblicare la sentenza di condanna.
Ciò posto, rimane la questione, prospettata dalle ricorrenti al di là della qualificazione datane, dell’ammontare del risarcimento, nel senso che le danneggiate pretendono che tale ammontare non coincida con il pregiudizio subito, ma debba essere riconosciuto nella maggiore somma corrispondente all’arricchimento derivatone per la società editrice.
La questione è dunque quella posta, da tempo, per il caso di arricchimento mediante fatto ingiusto. Vi sono ossia casi in cui il fatto illecito procura un arricchimento al danneggiante, che spesso è anche maggiore del danno inferto; casi in cui, come è noto, si è suggerito di prevedere che il danneggiato abbia azione per l’intero.
È questa, del resto, la soluzione corrente in Germania e nei sistemi di common law, dove nel caso in cui l’illecito produca un arricchimento per il danneggiante, costui risarcisce nei limiti di tale arricchimento, anche se superiore al danno inferto.
Le ricorrenti chiedono l’applicazione di una regola simile, che, come è noto, non è espressamente codificata nel nostro ordinamento, dove, anzi, vige il principio opposto secondo cui il risarcimento è limitato al pregiudizio subito e non deve superare il valore di quest’ultimo.
La tesi delle ricorrenti (risarcimento del fatto ingiusto non nei limiti del danno subito, ma in quello dell’arricchimento conseguito dal danneggiante), ripete una origine sostenuta in dottrina, secondo cui dal sistema sarebbe ricavabile un principio di divieto di arricchimento mediante fatto ingiusto, indicato da alcune norme significative: in primo luogo l’art. 1148 c.c. da cui si ricava, a contrario, che il possessore in mala fede deve restituire i frutti anche se superano quelli che il proprietario avrebbe potuto ricavare dalla cosa, dunque deve restituire l’arricchimento; e poi l’art. 2032 c.c. da cui si ricava, per interpretazione corrente, che ciascuno attraverso la ratifica può costringere chi ha compiuto affari ingerendosi nella sua sfera a riversargli gli utili ottenuti, ossia il guadagno fatto attraverso una gestione di affari illecita, come si deduce dal riferimento che la norma fa alla disciplina del mandato.
Infine, l’art. 125 del codice della proprietà industriale che obbliga l’usurpatore a restituire gli utili conseguiti usurpando.
Va prevenuta la fallace obiezione secondo cui queste norme hanno un ambito di applicazione propria, che ne impedisce l’estensione al di fuori del sistema per cui sono dettate. Ad esempio, l’art. 1148 c.c. può sembrare norma non applicabile fuori dall’ambito del possesso.
Chi propone una simile obiezione ovviamente confonde la funzione di regola di una norma, ossia la funzione di regolare un caso concreto, che ben può essere limitata ad alcuni rapporti e non estesa ad altri, con la possibilità che la norma, insieme ad altre, indichi un principio, possa cioè concorrere a far ritenere che l’ordinamento, prevedendo una serie di regole che obbligano l’autore della condotta alla restituzione dell’utile conseguito illecitamente, contenga un principio generale di arricchimento mediante fatto ingiusto.
Altro è l’ambito che una norma ha come regola del caso (per cui, ad esempio, la sua applicazione è limitata al possesso e non estensibile ad altre situazioni giuridiche), altro è il rilievo che la norma può avere come indice (da sola o unitamente ad altre) di un principio generale.
In sostanza, secondo la cennata corrente di pensiero, è ricavabile dal sistema una regola generale in base alla quale quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, costui deve risarcire nella misura dell’arricchimento se superiore a quella del danno inferto.
La ratio dell’istituto, ossia dell’arricchimento mediante fatto ingiusto, sarebbe quella di garantire la funzione preventiva del risarcimento, che altrimenti sarebbe vanificata.
Chi prevede che danneggiando un terzo ricava un guadagno maggiore del danno che infligge, e sa che dovrà restituire solo quest’ultimo, sarà portato a danneggiare, avendone comunque un vantaggio, pur dopo aver corrisposto il risarcimento.
La regola dell’arricchimento mediante fatto ingiusto mira ad evitare questo effetto scoraggiando l’illecito proprio attraverso la previsione di restituire l’intero arricchimento ottenuto.
Il danneggiato è in tal modo svincolato dai limiti dell’art. 2041 c.c., che non avrebbe in tal caso carattere sussidiario proprio per la sua coincidenza con il fatto illecito, o meglio la sua interferenza con esso, cosi che la necessità di risarcire nei limiti dell’arricchimento ricavato è il frutto della combinazione delle due norme.
Questa tesi, sostenuta in sede teorica, è però inadeguata al caso che ci occupa, ed in generale lo è anche rispetto al danno aquiliano in genere.
L’insieme delle norme che si sono viste sopra – e come forse più chiaramente si deduce dall’art. 125, comma 3 codice della proprietà industriale, che riconosce al titolare del diritto leso la restituzione degli utili realizzati dall’usurpatore- manifesta un principio diverso da quello, cosi ampio e generale, riferito sopra; ossia manifesta il principio che il profitto dell’autore dell’illecito rileva, nella determinazione del rimedio, quando è realizzato sfruttando indebitamente un diritto altrui, di natura proprietaria o che consente al titolare il godimento e lo sfruttamento del bene, indebitamente sottratto (lo sfruttamento) dal terzo per suo personale profitto.
In sostanza, l’arricchimento conta ai fini risarcitori se è frutto di una particolare condotta: quella di sfruttamento indebito di beni o risorse altrui.
In questi casi, infatti, può farsi anche applicazione analogica artt. 1148 c.c., e art. 125, comma 3 codice proprietà industriale.
Fuori da tali casi, è applicabile direttamente o analogicamente l’articolo, pure sopra richiamato, art. 2032 c.c., quando l’operato abusivo sia ratificato dal danneggiato, che dunque fa proprio l’utile netto.
In ogni altra ipotesi, se si ammettesse rilievo all’arricchimento, il danneggiato lucrerebbe una somma superiore al danno subito.
Ossia, la regola propria dell’illecito civile, secondo cui il risarcimento va commisurato al danno subito dal danneggiato, e non deve essere superiore a questo, potrebbe in ipotesi subire eccezioni quando l’illecito sia connotato dai presupposti propri dell’arricchimento senza causa, che sono, per l’appunto, quelli di una condotta di interferenza nei beni altrui, e di sfruttamento illecito delle loro potenzialità.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso presente, nel quale l’arricchimento del gruppo editoriale è consistito nel risparmio realizzato nel non aver sopportato i costi di pubblicazione, ed è un arricchimento che non solo non deriva dallo sfruttamento indebito del diritto altrui, ma è semplicemente insito nell’inadempimento stesso, ossia nella stessa mancata ottemperanza alla sentenza.
4.- Va dunque esaminato il secondo motivo, che è formulato, per l’appunto, in caso di rigetto del primo.
Con tale motivo si lamenta apparentemente violazione di legge (artt. 1226 e 2043 c.c.) addebitando alla corte di merito di aver violato le regole sulla liquidazione equitativa del danno, ma in realtà si propone una censura di motivazione apparente o insufficiente.
In quanto tale il motivo è infondato, dal momento che la corte ha indicato i criteri in base ai quali ha stimato equitativamente il danno: gravità della lesione, capacità diffamatoria degli articoli, e la rilevanza che la pubblicazione, se compiuta, avrebbe avuto.
Con la conseguenza che la motivazione non può ritenersi apparente, posto che fornisce giustificazione dei criteri adottati.
Nè può ritenersi sussistere violazione di legge, e particolarmente dell’art. 1226 c.c. in tema di equitativa liquidazione del danno, dal momento che i criteri utilizzati fanno riferimento esattamente al pregiudizio subito dalla mancata pubblicazione.
Si tratta, per come è evidente, di un danno di natura non patrimoniale poiché consiste nella mancata riparazione in forma specifica (la pubblicazione della sentenza di condanna mira a ricostituire la reputazione del diffamato) di un danno, a sua volta non patrimoniale, ossia la lesione della reputazione del soggetto diffamato.
La corte ha correttamente considerato, in questa prospettiva, quale sarebbe stata la diffusione del rimedio, se vi fosse stata ottemperanza, tenuto conto della tiratura e della diffusione territoriale dei quotidiani su cui andava effettuata la pubblicazione.
Ed è valutazione di merito qui insindacabile, addotta che sia una sufficiente motivazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.