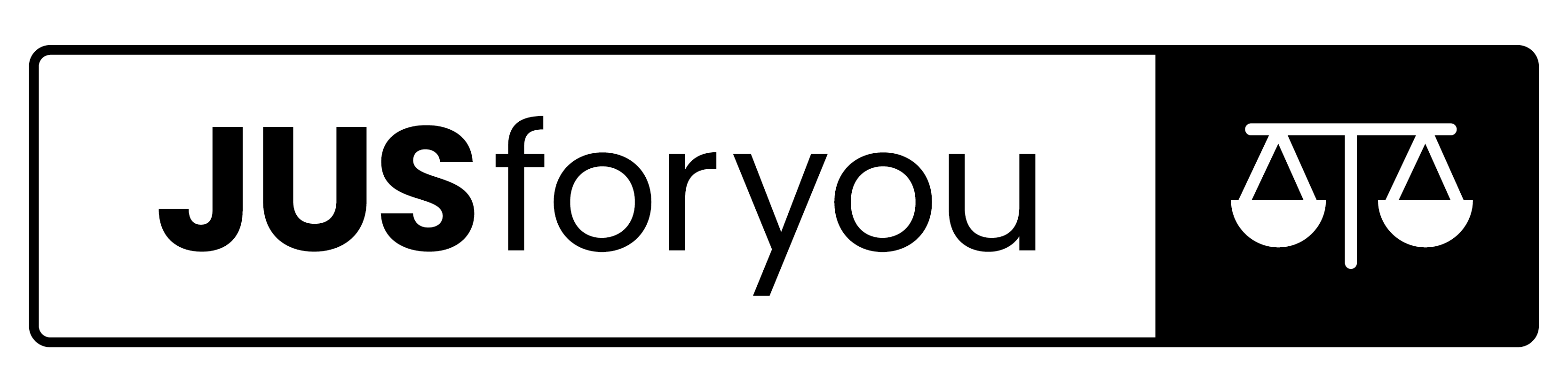Cass. Penale, Sez. Vi, 11 marzo 2025, n. 9906 – Pres. Fidelbo, Rel. Di Giovine
PARTE I) LA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE COLPOSA SVOLGE UNA FUNZIONE DI INCRIMINAZIONE PERCHÉ ATTRIBUISCE RILIEVO PENALE (E RENDE TIPICHE) ANCHE LE CONDOTTE IN SÉ PRIVE DI EFFICACIA EZIOLOGICA
La disciplina sulla cooperazione colposa, per quanto possa apparire – e sia spesso denunciata in dottrina come – obsoleta nel confronto con le organizzazioni contemporanee, consente di pervenire a soluzioni equilibrate, bilanciando le esigenze di personalizzazione della responsabilità penale con quelle politico-criminali legate al non corretto operato di strutture policentriche, segnate da un’inevitabile frammentazione decisionale a livello sia sincronico sia diacronico.
Il testo dell’art. 113 cod. pen. richiede, infatti, che l’evento sia “stato cagionato dalla cooperazione di più persone”.
Dovendo rappresentare il prodotto causale dell’interazione di plurimi soggetti, basta dunque che questi pongano in essere anche solo “pezzi”, “parti”, “frammenti” – purché significativi – dell’antecedente che ha condotto al risultato finale (la disposizione spiega, quindi, una funzione incriminatrice anche in rapporto a delitti colposi di evento in forma libera).
Specularmente, a differenza che nel c.d. concorso di cause colpose indipendenti, nella cooperazione colposa non occorre che l’evento sia riconducibile dal punto di vista causale ad ogni singola condotta; non si richiede cioè che, senza tale condotta, l’evento non si sarebbe verificato affatto, essendo piuttosto sufficiente che ciascun comportamento, seppure realizzato in momenti diversi rispetto ad altri , abbia avuto rilievo eziologico sulla produzione dell’evento concreto, nel senso che, senza di esso, questo avrebbe presentato caratteristiche (significativamente) diverse da quelle in effetti assunte.
Il che implica – sul piano della tipicità oggettiva – che condotta di partecipazione rilevante può essere anche quella che ha avuto valore condizionante in rapporto alla condotta di altro concorrente.
Tale soluzione si spiega alla luce dei principi generali e trova conforto, sul piano empirico, nella peculiarità del fenomeno interattivo colposo, in quanto l’intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, compenetrano con altre condotte tipiche.
PARTE II) NELLA COLPA SPECIFICA LA CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO SURROGA IL GIUDIZIO DI PREVEDIBILITÀ
La regola positivizzata surroga la prevedibilità dell’evento da parte di un agente modello, tipica della colpa generica: rappresenta, cioè, il frutto di un giudizio fondato sulla sedimentazione per via di “ripetizione” sociale della cautela e/o di un giudizio condotto su base scientifica. Il che accade negli ambiti in cui la predicibilità dell’evento sia decodificabile attraverso conoscenze appartenenti a domini specialistici e di cui l’uomo comune non dispone.
Ciò spiega perché, a fronte della crescente complessità tecnica e sociale della realtà e del graduale affinamento dei sistemi prevenzionistici in senso lato, si stia da tempo assistendo ad una progressiva espansione della disciplina normativa positivizzata, e la colpa specifica stia conseguentemente erodendo spazi un tempo occupati dalla colpa generica.
Il processo, con ogni probabilità inarrestabile, implica perdite in termini di personalizzazione del giudizio sulla responsabilità penale, a fronte, però, di un (quantomeno promesso) guadagno in chiave di maggior
certezza.
E, d’altronde, il modello della colpa specifica mostra un’utilità particolare in contesti in cui non sia possibile confidare nella c.d. percepibilità del pericolo, situazione para-psicologica suscettibile di scattare in presenza di alert, perché l’evento naturale (qui, la valanga) ha caratteristiche che rendono difficile prevederne non tanto l’an, quanto il quando e il quomodo.
PARTE III) LE POSIZIONI DI GARANZIA E IL PRINCIPIO DI INESIGIBILITA NELL’ACCERTAMENTO DELLA COLPA
POSIZIONE DI GARANZIA E POTERI IMPEDITIVI, ESERCITABILI ANCHE CON MODALITÀ SOLLECITATORIE NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE
Non è possibile scindere concettualmente la posizione di garanzia dal la disponibilità di poteri impeditivi dell’evento, dal momento che, diversamente, si incorrerebbe in un’antinomia.
I poteri impeditivi – giuridici e materiali – rappresentano, infatti, il presupposto concettuale della posizione di garanzia e vanno riferiti alla produzione dell’evento essendo inimmaginabile – se non a costo della suddetta insuperabile contraddizione logica o di una finzione giuridicamente inammissibile – un garante sguarnito del potere non soltanto giuridico, ma ancor prima materiale, di incidere sul decorso fattuale che conduce alla produzione dell’evento lesivo.
Il diritto non può obbligare qualcuno a fare qualcosa che non può fare.
Ciò precisato, è, però, altrettanto ovvio che, soprattutto nelle strutture complesse, ove il garante non sia nelle condizioni di esercitare egli stesso, in prima persona, un dominio diretto sulle sequenze causali produttive del l’evento, egli possa e, anzi, debba esplicare il suo potere fattuale in modo indiretto, vale a dire organizzando, coordinando, dirigendo e, se del caso, sollecitando gli organi a ciò preposti, nel rispetto della catena dei ruoli e delle responsabilità dell’ente.
Senza che ciò implichi alcuna semplicistica identificazione tra potere (materiale) impeditivo del garante e potere sollecitatorio, posto che quest’ultimo rappresenta, come detto, una mera manifestazione, una possibile modalità di esercizio del primo: insomma, una forma (insieme con altre) di gestione del rischio, al l’interno di realtà pluricentriche.
POSIZIONE DI GARANZIA DEGLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE RISPETTO ALLE CALAMITÀ NATURALI
Gli organi apicali del Servizio di Protezione civile rivestono una posizione di garanzia – specificamente, una posizione di protezione – rispetto agli eventi di disastro.
Quale che sia, infatti, la nozione di “posizione di garanzia” cui voglia adirsi, un ente – ogni ente – il quale svolga funzioni di protezione civi le è, per eccellenza, “gestore del rischio” su cui deve vigilare.
A tale conclusione si giunge ragionando: sulla base della (ormai, in sé, superata) teoria formale dell’obbligo giuridico (la fonte dell’obbligo essendo rinvenibile nella legge regionale); sulla base della concezione sostanziale (Garantenstel!ung), che individua su base fattuale i soggetti che si trovino rispetto ad altri in una posizione privilegiata, tale da materialmente consentire la tutela di beni che i loro titolari non possono difendere da soli (posizione di protezione) ovvero abbiano un rapporto qualificato con la fonte del rischio cu i altri sia esposto (posizione di controllo); sulla base della teoria mista (per parte formale, per parte sostanzia le), la quale cerca agganci normativi alla Garantenstel/ung, per mitigarne l’evanescenza applicativa, senza però snaturarne la ratio.
Va quindi ribadito che, al di là dell’impostazione che si reputi preferibile, non v’è dubbio che agli enti di protezione civi le (intesi sia quali organi politici, sia quali articolazioni amministrative) spetti il compito di amministrare il rischio per l’incolumità personale e collettiva: in tal senso recitando la loro stessa denominazione; in ciò risiedendo la ratio della loro creazione, il loro scopo istituzionale; a ciò essendo funzionalizzati i poteri conferiti dalla legge, in un raro caso di tendenziale, immediata convergenza tra finalità amministrative e gius-penalistiche.
LA DISTINZIONE TRA DOVERE DI DILIGENZA (DA CUI NASCE LA POSIZIONE DI GARANZIA) E DILIGENZA DOVEROSA (REGOLI MODALI CHE FONDANO IL RIMPROVERO A TITOLO DI COLPA)
Occorre distinguere tra “dovere di diligenza”, come situazione giuridica soggettiva che deve avere necessariamente una fonte giuridica (e che, quindi, si può chiosare, permette di individuare il soggetto attivo del reato), e “diligenza doverosa”, nozione invece riferita al contenuto della prima e che si sostanzia delle concrete modalità comportamentali di fonte normativa giuridica o anche socia le – volte a soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire imprudente o di agire in modo diligente (concetto che designa la colpa) (per tutte, Sez. 4, n. 32899 del 02/12/2020, dep. 2021, Castaldo, Rv. 281997, su l c.d. disastro di Viareggio; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barberi, Rv. 267811, sul terremoto de L’Aquila).
È opportuno precisare che tale distinguo, da un lato, vuole dare compiuta attuazione al principio di personalità della responsabilità penale, invertendo definitivamente la tendenza, che prevaleva in passato, a desumere semplicisticamente la colpa dall’esistenza della posizione di garanzia.
Dall’altro lato e prima, nella misura in cui chiama il giudice ad operare una ricognizione del “dovere di diligenza” (diversa dal la ricognizione della “diligenza doverosa”), l’impostazione in esame sollecita una accurata ana lisi delle diverse sfere di responsabilità gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, allo scopo di operare la selezione dell’area del rimprovero penale già sul piano della tipicità oggettiva.
LA PLURALITÀ DEI GARANTI NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE: LA DIFFICOLTÀ DI DIFFERENZIARE I RUOLI SULLA BASE DELLE QUALIFICHE FORMALI, LE RETI RELAZIONALI E LA RECIPROCA INTERAZIONE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO
Nel l’ambito delle organizzazioni complesse va contrastata la tentazione di definire in modo “atomizzante” il ruolo di ciascun garante.
Le stesse Sez. U. n. 38343 del 18/09/2014 avvertono che occorre guardarsi dal l’”idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine”.
Al di là delle difficoltà pratiche, selezionare tra le tante disposizioni legislative quelle funzionali a costruire tale ruolo rischia: di rivelarsi un’operazione arbitraria; di trascurare l’ovvia considerazione che la specifica individuazione legislativa di compiti e poteri in capo a singoli soggetti può essere asservita a finalità diverse da quelle proprie del diritto pena le (precipuamente teso al la protezione di beni giuridici) e non sempre ad esse riconducibili; di pretermettere come la scienza del le organizzazioni sempre più frequentemente parli del la necessità che all’interno delle strutture si realizzino interazioni operative, evitando compartimentazioni stagnee, sulla base dell’assunto che “organizzazione” significa divisione dei compiti, ma anche coordinamento tra gli stessi (il concetto ha, cioè, un’inevitabile connotazione relazionale).
Su un piano genera le, anche là dove si abbia a che fare con strutture dotate di organigrammi ben definiti, è dubbio che l’allocazione della responsabilità penale si possa accontentare di ripartizioni formali di compiti, e non debba piuttosto, a partire da queste, penetrare a fondo concreti assetti decisionali del l’organizzazione, cercando di decodificare le reti di relazioni, così da coglierne le reali logiche operative e la
“catena di comandi e di controlli” cu i effettivamente risponde.
L’impresa di definire con analitica precisione le competenze sarebbe, comunque, impropria e potenzialmente arbitraria. Si rivelerebbe inoltre, nel la migliore delle ipotesi, inutile, perché duplicherebbe il giudizio colposo.
Del resto, l’attribuzione di ruoli da parte della legge extrapenale ben può dipendere da finalità diverse e non coincidenti con quelle gius-penalistiche, tutte invece convergenti verso la tutela di beni giuridici.
Delimitare tali ruoli con acribia, pensando di ritagliare con chirurgica precisione “sfere di rischio” di dubbia consistenza penalistica, equivarrebbe, dunque, a sacrificare la stessa elaborazione concettuale della posizione di garanzia sull’altare di visioni burocratizzanti e formalistiche.
Visioni che, peraltro, nemmeno trovano riscontro nei principi della moderna scienza aziendalistica, intenta ad evidenziare come, in tema di organizzazioni complesse, si sia passati da modelli verticali, caratterizzati da confini organizzativi ed accentramento decisionale, a strutture di tipo misto e più flessibile (come quella divisionale e a matrice), per giungere a strutture orizzontali, basate su team e processi (si pensi alla c.d. adhocrazia, opposta alla burocrazia e segnata da un elevato tasso di decentramento dei processi decisionali, dinamicità e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze) ed infine alla c.d. organizzazione network, in cui gli individui pongono in essere azioni reciproche e di mutuo supporto, orientate al risultato (modelli cui, com’è evidente, non potrebbe attagliarsi una rigida distinzione di “ruoli”).
LA RISTRETTEZZA DELLE RISORSE FINANZIARIE E DI PERSONALE COME POSSIBILE CAUSA DI INESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA CONFORME AL DOVERE CAUTELARE. LE INTERAZIONI DOVEROSE {TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE) IN ORDINE ALL’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ALLE STRUTTURE OPERATIVE
La categoria dell’esigibilità, che denota la rimproverabilità ed integra, quindi, la colpevolezza (in senso normativo) del reo, quale ultimo momento del reato, si sta gradualmente facendo strada nella giurisprudenza di questa Corte, perché ha il merito di esternare una crescente attenzione per i profili, costituzionalmente rilevanti, della personalità della responsabilità penale.
Ciò nondimeno, non ci si nasconde che la valutazione sull’esigibilità della condotta conforme a dovere, proprio in ragione dell’individualizzazione del rimprovero che comporta, è molto delicata perché comporta inevitabili margini di discrezionalità, e sollecita, dunque, i giudici di merito a svolgerla con un’attenzione affatto particolare.
Quand’anche i giudici del rinvio pervengano a ritenere che gli imputati non erano in grado di ottemperare alla condotta doverosa a causa del le circostanze di contesto fattuale, non potranno esimersi dal ricostruire i meccanismi che portano in ad attribuire al le articolazioni amministrative le dotazioni di organico e le somme necessarie per adempiere ai compiti istituzionali, essendo ragionevole supporre, salvo prova del contrario, che gli organi politici, agiscano su sollecitazione e in raccordo con le amministrazioni: le uniche ad avere il “polso della situazione” e, pertanto, le sole in grado di mettere a fuoco ed evidenziare, denunciandoli, deficit e lacune operative, anche sopravvenute, del sistema.
La valutazione andrebbe cioè svolta anche al la luce di quanto in precedenza accennato sull’interazione che in organizzazioni complesse è necessario si instaurino tra soggetti pur dotati di diversi ruoli ed operanti a vari livelli (nel caso di specie, politico ed amministrativo), le cui attività devono, però, comunque convergere verso la realizzazione di un interesse del pubblico (che rappresenta la ragion d’essere del Servizio).
Trattandosi di soggetti tenuti a raccordi e scambi informativi, i giudici di merito dovranno, in altre parole, ricostruire le iniziative interlocutorie degli imputati, avendo anche in questo caso riguardo ai ruoli, al tempo per cui tali ruoli furono rivestiti e alle condotte di ciascuno, per verificare ed eventualmente graduare il rimprovero conseguente all’eventuale inerzia di ciascuno.